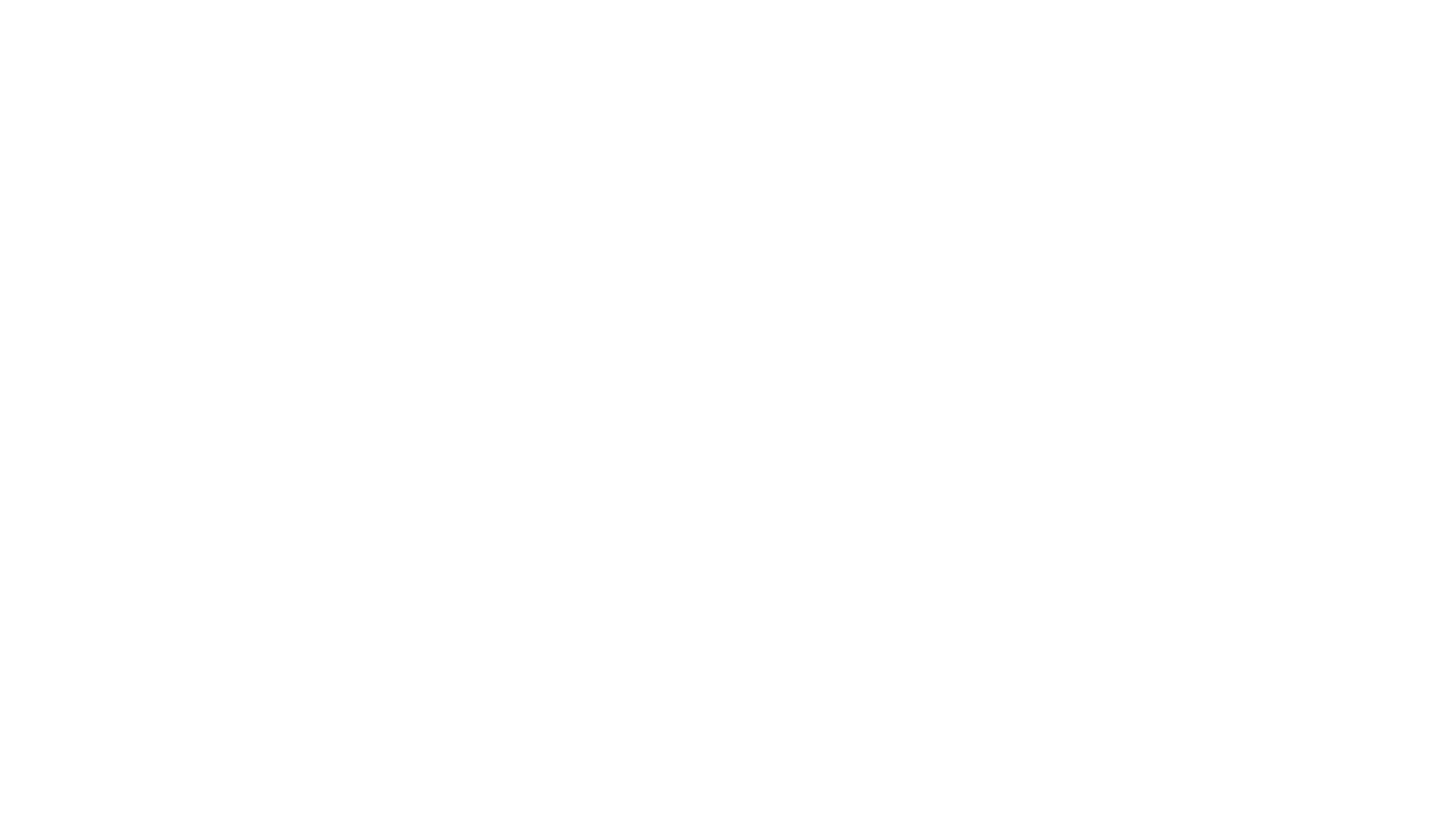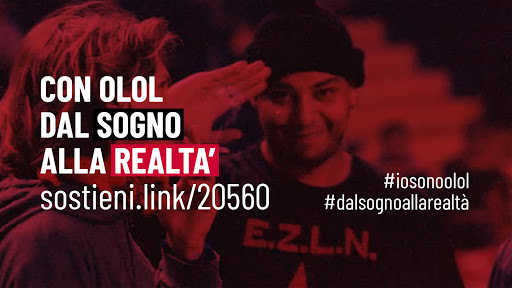Con questa intervista a Marta Fana – dottoressa di ricerca in economia a Science Po di Parigi – apriamo un ciclo di interviste a ricercatori e testimoni privileggiati sui temi del lavoro e dell’organizzazione sindacale.
Il nostro obbiettivo è quello di riflettere sul contesto sistemico e sulle grandi trasformazioni che fanno da cornice alle nostre vertenze e pongono vincoli ma anche opportunità all’azione sindacale.
L’Istat ha recentemente pubblicato i dati sul mercato del lavoro. I dati sembrerebbero certificare il fallimento delle promesse alla base degli ultimi interventi normativi sulle forme d’impiego e i contratti di lavoro. Promesse di un aumento sostanziale dell’occupazione e dei contratti a tempo indeterminato. Nonostante l’investimento di numerosi miliardi per garantire la decontribuzione delle assunzioni si registra invece il perdurare di una crescita più che tiepida degli occupati trainata dalla crescita dei contratti a termine e una disoccupazione giovanile che continua a stare attorno al 40%. Qual è la tua interpretazione delle recenti dinamiche del mercato del lavoro in Italia? Ci puoi dare una tua interpretazione degli effetti delle recenti riforme?
La dinamica recente del mercato del lavoro mostra la sua costante precarizzazione, prima e durante la crisi, cioè ancora oggi. A meno di non voler pensare che ne siamo già usciti. I contratti a tempo indeterminato diminuiscono costantemente da più di dieci anni in termini di dinamica complessiva e questo è il primo effetto delle riforme del mercato del lavoro, di cui il jobs act è soltanto l’ultimo, feroce tassello. Certo, nel 2015 con più di 15 miliardi regalati alle imprese le assunzioni permanenti sono aumentate, però analizzando il dato in termini complessivi non possiamo non notare che: 1) i nuovi occupati definiti permanenti hanno un contratto a tutele crescenti nella maggioranza dei casi, quindi un contratto per definizione instabile; 2) l’aumento occupazionale non ha mostrato alcun effetto espansivo e questo è ovvio se consideriamo l’andamento del sistema economico nel suo complesso, che rimane stagnante 3) i nuovi contratti permanenti sono sempre più spesso part-time, tra cui cresce anche la quota dei part time involontari 4) se da un lato gli sgravi hanno trainato l’aumento dell’occupazione nel 2015, non possiamo non riconoscere che questa sarebbe comunque lievemente ripartita data la seppur lieve ripresa congiunturale. Questo a ribadire che gli sgravi non sono altro che un regalo netto alle imprese 5) infine, su questo punto la cosa più importante forse è notare come i nuovi occupati sono assorbiti in settori a scarsa produttività.
Le politiche di flessibilizzazione del lavoro, sia in entrata sia in uscita, non sembrano avere delle correlazioni significative con l’aumento dei tassi di occupazione. In compenso sembrano aver agito come dei potenti dispositivi per abbassare il costo del lavoro. Qual è la tua opinione a riguardo?
La letteratura economica che si concentra sui fatti e dati che emergono dalla realtà ha smentito il legame positivo tra flessibilizzazione e occupazione. Risultato del tutto coerente anche con la teoria neoclassica, cioè quella dominante secondo cui la libertà di aggiustamento della forza lavoro all’interno delle imprese- per intenderci, la possibilità di licenziare e di assumere con contratti che prevedono minori tutele reali, salariali e contributive – agisce prima di tutto sui salari, spingendoli verso il basso. In un contesto in cui la disoccupazione è elevata e gli strumenti di tutela nonché quelli rivendicativi dei lavoratori vengono meno, è ovvio che le imprese assumono il comando totale sia in termini di pressione sulle scelte di governo (le riforme, gli sgravi) sia sui lavoratori stessi (o i contratti precari o la disoccupazione).
I tassi di occupazione molto spesso nascondono situazioni di lavoro marginale, iperprecario e povero. Il cosiddetto fenomeno dei working poors. Anche economie che sembrerebbero avere livelli di disoccupazione più bassi, pensiamo a gli Stati Uniti o la Germania, nascondono questa realtà. Le statistiche sul mercato del lavoro dovrebbero quindi essere sempre accompagnate da una analisi sui livelli salariali e il potere d’acquisto. Non credi?
Oltre che un’analisi più dettagliata delle diseguaglianze salariali all’interno del mondo del lavoro, credo sia necessario dotarsi di approfondimenti relativi all’intensità del lavoro e qualità del lavoro. Un dato che emerge troppo poco nel dibattito è proprio la sottoccupazione fortemente associata al precariato diffuso. Dall’altro lato della scala invece abbiamo forme intensive di sfruttamento della forza lavoro in cui i tempi di lavoro sono portati all’estremo. La coesistenza di questi due aspetti oltre che alle diverse forme contrattuali deriva anche dal trattamento degli straordinari, defiscalizzati, usati come base per i premi aziendali, ecc.
L’innovazione tecnologica, tra cui l’intelligenza artificiale, e i processi di delocalizzazione sembrano aver messo fuori gioco, almeno in Europa, le politiche delle piena occupazione di stampo keynesiano. Quali sono i settori occupazionali che, all’interno di questo scenario, continuano ad esprimere un’elevata domanda di lavoro?
Non confondiamoci, l’abbandono delle politiche di piena occupazione sono scelte che prescindono dall’innovazione tecnologica e risiedono nella volontà di anteporre stabilità dei prezzi e competitività tra gli stati all’interno dell’Unione Europea. La questione tecnologica è un altro pezzo del discorso. Per capire le dinamiche in essere ci sono differenze enormi tra i diversi paesi europei. Ad esempio la Gran Bretagna è diversa dall’Italia: la prima ha da decenni puntato su uno sviluppo basato quasi esclusivamente sulla finanza, noi rimaniamo comunque un paese industriale. Nel primo caso i processi di robotizzazione sono molto più invasivi, da noi vanno ricostruiti ampi settori, in cui la robotizzazione centra poco in termini di disoccupazione, ad esempio tutti quei settori a garanzia dei diritti di cittadinanza: scuole, ospedali, diritto alla casa in cui il disinvestimento e la sottocupazione è a livelli elevati. Ci sono poi i settori in cui si assiste a enorme polarizzazione, per eccellenza mi riferisco all’industria dove se a monte la produzione è stata robotizzata almeno in parte, rimane tutta la seconda fase del ciclo- quella della circolazione delle merci- in cui la domanda di lavoro e l’intensità del fattore lavoro è elevata (logistica, grande distribuzione). Ancora, per quanto riguarda l’Italia, la domanda di lavoro potrebbe venire dall’investimento in infrastrutture, dalla ricerca di base, dal settore pubblico stesso. Tra l’altro noi abbiamo urgente bisogno di produrre tecnologia e governarla, a meno che non si voglia avallare l’idea che saremo per sempre un paese importatore netto di tecnologia.
A nostro avviso tuttavia ci sembra improcrastinabile un serio ragionamento sull’orario di lavoro e su un reddito minimo garantito. In Francia addirittura un candidato della Partito Socialista sembra essersi orientato su questa strada.
La riduzione dell’orario di lavoro non è solo un ragionamento improcrastinabile quanto un obiettivo politico da raggiungere nel più breve tempo possibile. Si tratta infatti di un provvedimento che permetterebbe al contempo di ridurre la disoccupazione, ma soprattutto se praticata a parità di salario (altrimenti sarebbe il formato amazon di cui non abbiamo bisogno) corrisponde anche a uno strumento di aggressione a quella quota profitti in costante aumento a detrimento della quota salari. Conviene anche ribadire che l’aumento della quota dei profitti (e delle rendite )sul reddito è causa principale dell’aumento delle diseguaglianze in questi ultimi decenni. Altro punto non meno importante, se da un lato abbiamo bisogno di una riduzione generalizzata dei tempo i lavoro, dall’altro non possiamo però pensare che questa possa essere decisa esclusivamente per legge, dovrebbe infatti essere punto negoziale all’interno dei luoghi di lavoro ristabilendo un principio cardine: la possibilità per i lavoratori di incidere sull’organizzazione stessa del lavoro in cui i tempi sono variabile determinante.
Quanto al reddito, sicuramente uno strumento di sostegno è indispensabile, ma dobbiamo stare attenti anche di fronte alle recenti proposte come quella di Hamon (o Bill Gates): ridurre il tema della redistribuzione a quello del reddito è non soltanto parziale come prospettiva ma anche miope. In termini generali, in Italia abbiamo bisogno di una rivoluzione del welfare: non solo reddito, ma anche case, scuole ospedali, treni per le periferie e più in generale trasporto pubblico. Senza questi altri pezzi il reddito non fa molto. In secondo luogo credo che il nodo principale sia come teniamo uniti la produzione e il reddito, a chi diamo il diritto di decidere il cosa come e quanto produrre, perché senza il governo di queste decisioni si crea una netta separazione tra chi detiene i mezzi di produzione e decide cosa e come produrre e chi invece consuma (beni e servizi determinati altrove). Credo che non possiamo prescindere da questo pezzo di ragionamento che pone come obiettivo più la distribuzione che la redistribuzione del reddito ecc, in un ottica collettiva e non individuale. Il conflitto non può esaurirsi in ottica redistributiva separandolo dalla direzione politica dei processi (proprietà, controllo e governo delle cose).