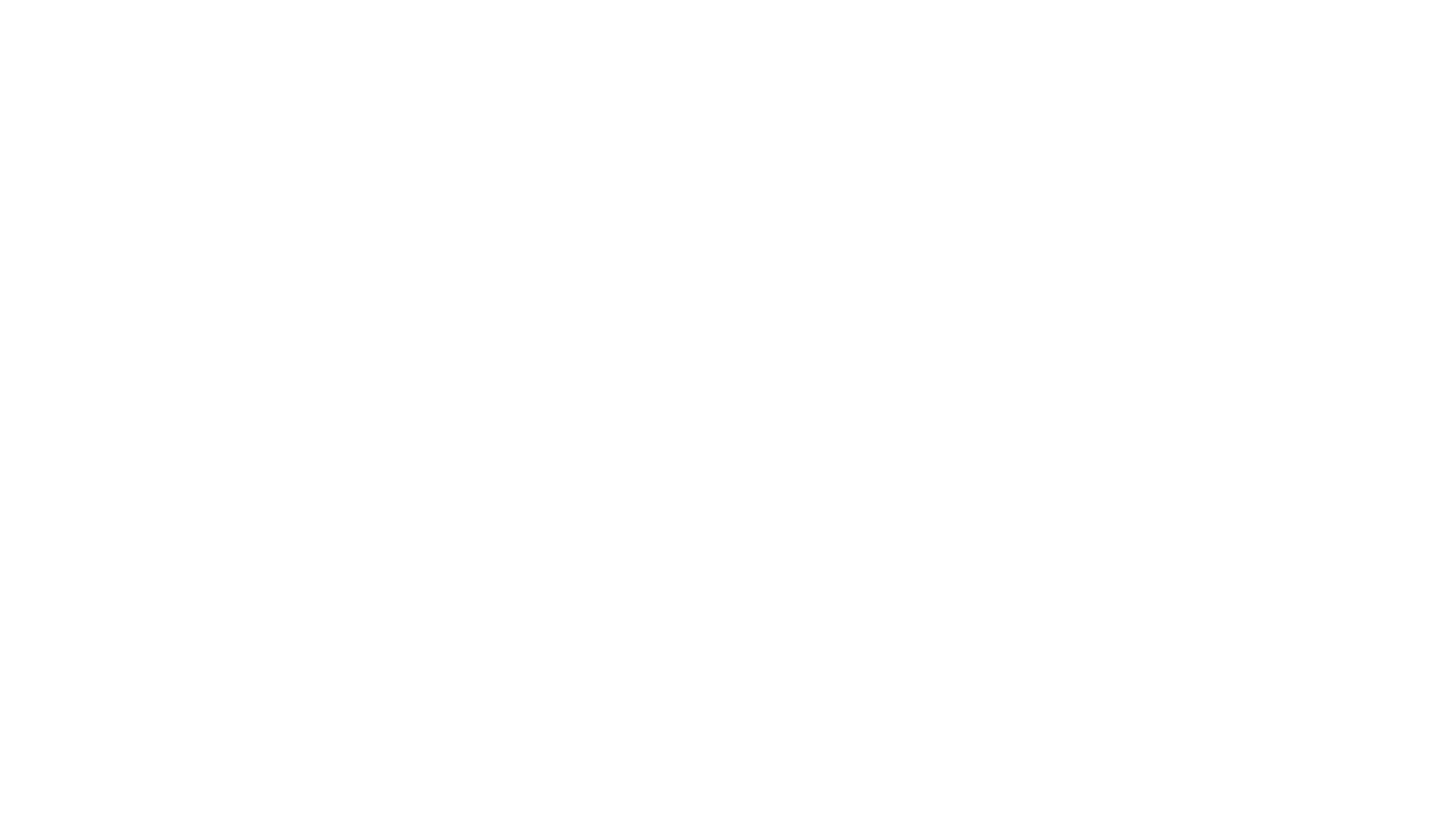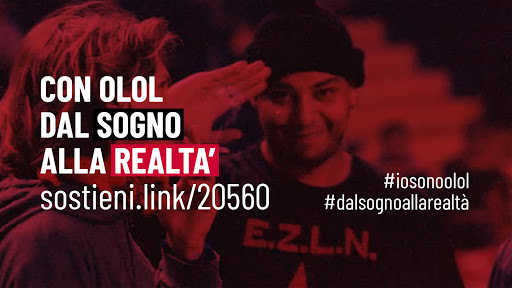In Europa per lavorare meno.
Il 25 marzo si è celebrato in pompa magna il 60° compleanno dell’Unione Europea cercando di nasconderne il suo fallimento politico e istituzionale: il nuovo protocollo d’intesa delinea una Europa a 2 velocità, un pool di paesi aggrappati alle gonne della Merkel che, ufficialmente, diventa il capo treno della locomotiva europea, coadiuvato da ossequiosi controllori che si impegnano a verificare l’idoneità di tutti coloro che vogliono salire a bordo.
Fuori di metafora non è insensato affermare che si ritorna, contestualizzando la situazione geopolitica mondiale, a quel mercato comune europeo che ha rappresentato 60 anni fa l’incipit dell’Europa del boom economico post bellico. La differenza sostanziale è data dal fatto che allora si arrivava alla firma del trattato europeo dopo 10 anni di crescita economica, ora ci si arriva dopo 10 anni di crisi, una crisi di cui, più che l’uscita, si intravvedono i margini del precipizio, in Italia e nell’Europa mediterranea più che altrove.
Inoccupazione giovanile che si aggira sul 40%, una fascia di povertà sociale che ricomprende ¼ della popolazione, il PIL che galleggia, la produzione manifatturiera che procede con continui stop and go e a macchia di leopardo sia territorialmente che settorialmente, un decadimento qualitativo e quantitativo di tutto quello che è aggrumato sotto la voce servizi, dalla sanità all’università, passando per il sistema creditizio. Ora la contabilità economica ufficiale spera di migliorare uno 0 virgola grazie alla ripresa della crescita inflazionistica, facendo finta di non sapere che l’inflazione, appunto, mangia il già misero potere d’acquisto di salari e stipendi, in Italia i più meschini dell’Europa che si vorrebbe ad alta velocità.
Eppure di rinnovo dei contratti – pubblici o privati che siano – non se ne parla, se non nelle segrete stanze, ma soprattutto non si lotta, se non quando si è alla frutta o a fine corsa. Eppure i problemi ci sono tutti, sono sentiti ed anche discussi ma pochi ci credono veramente, il disincanto politico e sindacale è veramente radicato e trasversale.
Nel 2015 il Jobs Act garantiva che incentivi e minori protezioni nei licenziamenti avrebbero ridotto il grande mare della precarietà. Invece i contratti a termine sono aumentati dal 62% del 2014 al 65% del 2016, senza parlare di voucher o di lavoro schiavistico. Si sono buttati al vento oltre 18 miliardi, secondo le stime di ADAPT, per favorire le imprese in una competizione produttiva a perdere, basata sulla riduzione dei diritti dei lavoratori, anziché sul know-how, per dirla in termini marxiani sull’estrazione di plusvalore assoluto anziché relativo. Fuori dal tempo e dallo spazio per un’economia che si proclama essere nel fulcro del capitalismo.
In Italia si lavorano mediamente 1800 ore l’anno contro le 1500 di Germania e Francia, con una remunerazione inferiore di circa 1/3 e ancora si continua a blaterare di fannulloni, di assenteismo, di rigidità – leggi diritti – che inceppano il mercato del lavoro, quando è conclamato che solo una ristretta minoranza di occupati gode delle garanzie conquistate con le lotte del secolo scorso. Un secolo fa appunto.
Si tratta, dunque, di riuscire ad indicare – a praticare – un’alternativa ad una potente onda ideologica che da quarant’anni, mettendo insieme il «fare di più con meno» (meno magazzino, meno tempo, soprattutto meno occupati stabili) del toyotismo e il «farsi imprenditori di se stessi» dei nuovi lavoratori interconnessi nella Rete, ha destrutturato le regole e i diritti conquistati con il lungo ciclo di lotte nei sessant’anni del fordismo e che avevano trovato nei contratti la loro formalizzazione. È urgente una suggestione, un’alternativa, trasversale e unificante, che può trovare forza nella richiesta generalizzata della riduzione dell’orario di lavoro: lo sviluppo tecnologico lo ha reso possibile anzi necessario, tanto più quando la pervasività del sistema produttivo capitalistico ha messo in produzione l’intera vita sociale, i nostri corpi e le nostre menti.
Domenico de Masi, vecchio sociologo del lavoro, recentemente ci ha ricordato che nel testo ‘Prospettive economiche per i nostri nipoti’, del 1930, Keynes scriveva: se nella fase in cui le tecnologie moderne saranno sviluppate, la settimana lavorativa sarà ancora superiore alle 15 ore, la disoccupazione schizzerà alle stelle.
John Maynard Keynes, l’ispiratore del New Deal, quello amato e sbandierato da tutti i riformisti e socialdemocratici, quello che noi definevamo un ‘vaselina’ della lotta di classe, non Toni Negri o i teorici del ‘rifiuto del lavoro.
Un’idea forza, quella della riduzione dell’orario di lavoro, che è stata al centro del dibattito nell’esperienza delle ‘nuit debout’ del passato anno, che ha trovato posto [32 ore x tutti] nel programma elettorale per la presidenza della Repubblica francese del socialista Hamon, un richiamo nelle linee guida di ‘Podemos’, un vago accenno in quelle del tedesco Martin Schulz competitor della Merkel. Niente di tutto ciò qui da noi, in tutte le sinistrate sinistre, nei sindacati e neppure nelle manifestazioni – tutte, al netto del preventivo terrorismo di Stato, autorappresentative e autoreferenziali, così come lo hanno raccontato i numeri – del 25 marzo pro o contro l’Europa. Si tratta di porla, di provarci, con calma, con determinazione