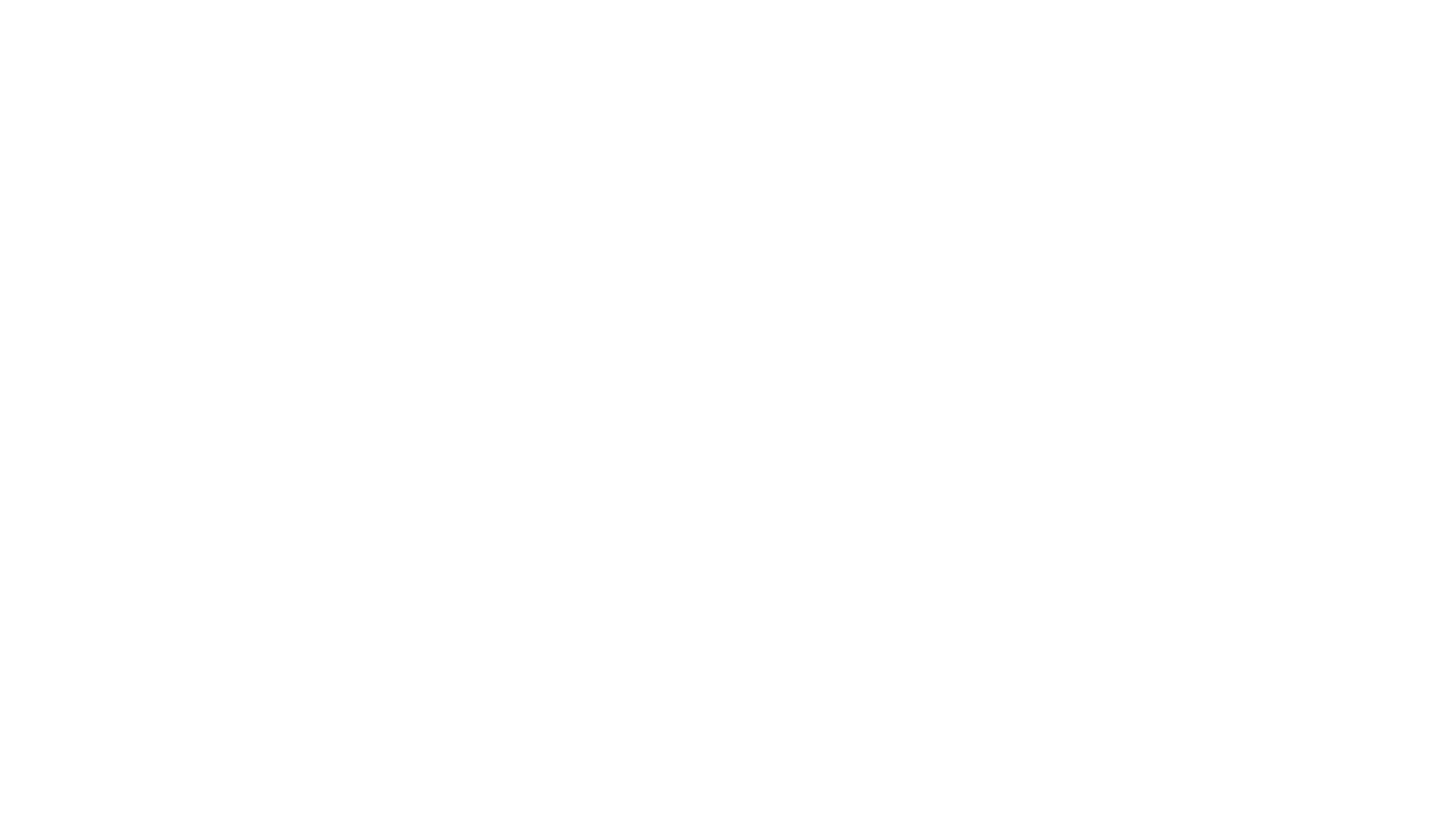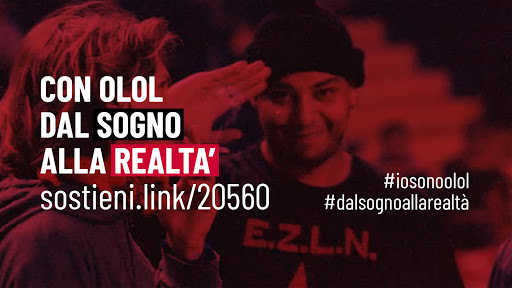Dopo la morte di Paola Clemente, stroncata da un infarto 2 anni fa, mentre lavorava all’acinellatura dell’uva è stato approvato una modifica del reato di caporalato allargandolo all’imprenditore. Bene ma ….
Siamo uomini o caporali? Il nuovo art. 603 bis c.p.
di Alessandro Brunetti – tratto da lavorovivo.it
A distanza di cinque anni dall’ultima novella si è intervenuto ancora una volta sull’articolo 603-bis del codice penale, contenente il reato di Intermediazione illecita e Sfruttamento del lavoro. L’azione di governo era evidentemente rivolta ad un ambito immaginato come specifico e marginale, una sorta di mercato differenziale, dedicato alle forme più estreme e violente di spoliazione e profitto. Ciò senza accorgersi che tutti gli interventi normativi sul lavoro posti in essere (quantomeno) dal pacchetto Treu ad oggi, hanno prodotto smottamenti tali da allargare a dismisura gli effetti giuridici della fattispecie, ben oltre le intenzioni degli estensori.
Tale ultimo intervento normativo formalmente nasce dall’esigenza di colpire in maniera maggiormente significativa il fenomeno del c.d. “caporalato” che non solo è ad oggi molto presente, in particolare in alcuni settori produttivi quali l’edilizia e l’agricoltura, ma è apparso quasi immune agli inasprimenti delle pene previste dalle cennate recenti riforme. In particolare numerosi sono stati i fatti di cronaca che hanno imposto tale ultimo processo normativo. Un numero sempre crescente di morti che hanno insanguinato le campagne del nostro paese non facendo distinzioni di sorta tra nazionalità ed etnie. Morti di fatica, laddove lo sfruttamento del lavoro corrode la vita fino all’osso non trovando più nessun limite normativo, sindacale o politico a controbilanciare con il conflitto il ritmo molare e spietato del profitto, sostanziando così zone speciali dove vige un presente ottocentesco. Con ciò ovviamente non si intende negare la sussistenza delle evidenti differenze che nella maggior parte dei casi tutt’ora persistono tra cittadini italiani e stranieri in fuga da miseria e guerra, disposti a lavorare in condizioni inimmaginabili, ma si vuole solamente evidenziare l’inarrestabile movimento “espansivo” di una miseria dai tratti tipici della premodernità. Quello che appare evidente è che tale processo esonda continuamente dal perimetro che il tema del caporalato normalmente richiama, ovverosia un fenomeno relegato al sud del paese, diffuso nel lavoro agricolo e gestito da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali. Lo sfruttamento – la sperequazione totale del massimo profitto in cambio di nulla o quasi – è ovunque, in ogni settore produttivo, al di là dell’identità anagrafica o della nazionalità di provenienza. Investe il processo produttivo in quanto tale attraversando tanto il lavoro manifatturiero (o quel che ne resta) quanto il lavoro cognitivo, il lavoro salariato ed il lavoro autonomo, il tempo del lavoro formalizzato come tale ed il tempo della produzione che abbraccia l’intera vita tal quale: il potere totalizzante e pervasivo dell’accumulazione capitalistica si estende voracemente sulla vita degli esseri umani.
Il “caporale”, inteso come figura che produce e si nutre del massimo grado di mercificazione del lavoro umano, dal punto di vista convenzionale è l’intermediatore che si frappone tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Ma da quello sostanziale può essere l’utilizzatore – il datore di lavoro diretto – che va dal padroncino informale al piccolo imprenditore, dal titolare dell’esercizio commerciale sotto casa alla media e grande impresa che con l’intricato reticolo di appalti e subappalti ricava continuamente valore agendo tra filiere nazionali e transnazionali che garantiscono manodopera a bassissimo costo e ricattabilità massima. Il caporale da figura ben definita e storicamente abbietta, diviene molteplice polverizzandosi in un’attitudine, una forma di vita, vi è una “caporalizzazione” del padronato che naviga verso i lidi della massimizzazione dei profitti sul dolce vento della crisi – fortissimo evocativo simbolico – che rende socialmente accettabile la generalizzazione delle condizioni lavorative inumane. L’abbietto è la norma e la miseria della precarietà l’unico mondo conosciuto ai più. Di questa realtà il governo Renzi è stato sommamente responsabile. Il Decreto Poletti liberalizza il termine nei contratti, il Job Act abroga il progetto nelle co.co.co., indebolisce le norme a garanzia della formazione nel contratto di apprendistato e autorizza il demansionamento rendendo la tutela della propria professionalità un lusso. Inoltre è stato autorizzato il controllo a distanza per sorvegliare ed è stato liberalizzato il licenziamento di ogni ordine e grado per punire. Se “il caporale” classicamente inteso non si limita al reclutamento ma sovraintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l’uso dell’intimidazione o della violenza, oggi non si fatica a rinvenire simili condizioni in ogni rapporto di lavoro innervato dalla precarizzazione generalizzata che abbraccia indistintamente sia la nuova subordinazione (priva di ogni tutela reale dai licenziamenti illegittimi) che i sottotipi contrattuali rientranti nell’area della finta autonomia della prestazione, per arrivare ai rapporti realmente autonomi ma miserabili in quanto assolutamente dipendenti dal punto di vista socio/economico.
Ed ecco la torsione caporalizzante della gerarchia di comando che innerva e qualifica ogni scambio tra salario e lavoro, sia esso contrattualizzato che non.
Dentro questo scenario il parlamento dopo un decennio di ablazione e sterilizzazione dell’efficacia dei diritti sociali e del lavoro, probabilmente senza rendersene minimamente conto, situa la nuova formulazione dell’art. 603 c.p. ben oltre i recinti tipici della fattispecie per alzarla al livello della realtà quale è.
Utilizziamo il titolo per anticipare l’analisi:
“Intermediazione illecita e Sfruttamento del lavoro”, non ci si trova innanzi ad un’endiadi ma a due distinte ipotesi che elevano lo sfruttamento del lavoro in quanto tale ad una fattispecie di reato che può atteggiarsi sia nei rapporti di lavoro diretti che nei rapporti triangolati dall’intermediazione di manodopera (lavoratore, fornitore ed utilizzatore).
Entriamo nel merito.
La fattispecie di reato in esame prevede la pena della “reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato” a fronte di due distinte e separate ipotesi:
ovverosia chi
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
o chi
utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
come si vede i due punti appena richiamati intervengono su due ipotesi differenti:
il primo caso allude alle forme di caporalato “classico” e riguarda un qualsivoglia rapporto triangolare dove intervengono tre soggetti, il fornitore di manodopera, il lavoratore e l’utilizzatore che affida “l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario”. Ovviamente la fattispecie di reato in questione abbraccia qualsivoglia ipotesi si dia: quella “corsara” e autorizzata delle agenzie di lavoro in somministrazione e quella “piratesca” non autorizzata di chi non è un’agenzia iscritta all’apposito albo.
il secondo caso, prescinde totalmente dalla fattispecie tipica richiamata dal titolo e quindi arriva a normare ipotesi dove non sussiste affatto l’intermediazione (assumendo così il legislatore, indirettamente e con tutta evidenza involontariamente, il dilagare dello “sfruttamento” nella fisiologica articolazione binaria dei rapporti di lavoro) e fa evidente riferimento ad un rapporto diretto tra lavoratore e utilizzatore/datore di lavoro.
In entrambi i casi la fattispecie in esame prevede la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:
il lavoratore deve trovarsi in uno stato di bisogno, ovverosia deve trovarsi costretto a lavorare per garantire la sussistenza propria e quella della sua famiglia (dunque si devono escludere i soli casi di chi, abbiente per estrazione, abbia scelto di lavorare per vivere un’esperienza “estrema”).
il lavoratore deve essere sottoposto a condizioni di sfruttamento i cui indici qualificatori sono indicati al comma successivo.
Il secondo comma quindi individua gli indici rivelatori di ciò che può essere considerato “sfruttamento”:
“Ai fini del presente articolo, costituisce
indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;” ovverosia tutti i casi in cui la retribuzione sia difforme da quanto spettante in relazione al mansionario svolto. Dunque ci si riferisce a tutti i casi di sotto inquadramento contrattuale ma, andando oltre, è agevole immaginare gli effetti della norma in esame sulla rete dei subappalti sia nel privato (simulati e non) che nel pubblico, in relazione ai lavoratori formalmente alle dipendenze di piccole cooperative o di società pronte all’uso e alla potenziale rottamazione, che forniscono manodopera strutturale alle grandi imprese o alla pubblica amministrazione. Ovviamente percependo la ben più misera (rispetto a quella che sarebbe dovuta se fossero assunti alle dirette dipendenze dell’effettivo utilizzatore) retribuzione imposta dal formale datore di lavoro quale conseguenza del contratto collettivo applicato da questi.
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; ovverosia i casi in cui sono riconosciute ferie o attribuiti orari di lavoro difformi da quelli previsti dalla contrattazione oppure viene negata l’aspettativa obbligatoria o i riposi settimanali.
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Ipotesi che richiama e mette in discussione la legittimità e l’operatività delle nuove norme previste dal Job Act che di fatto liberalizzano i controlli a distanza anche per il tramite dei dispositivi mobili quali telefoni e tablet. Ovviamente condizione lavorativa degradante è altresì quella ove la violenza psicologica, il ricatto e la sperequazione dei rapporti di forza si pongano in violazione sostanziale con i principi fondamentali costituzionalmente presidiati. Non da ultimo dunque il rimando alla cancellazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori e quindi alla ricattabilità che concretamente consegue al fatto di essere esposti alla possibilità di essere licenziati in assenza di alcuna giusta causa o giustificato motivo con la certezza che in ogni caso non si potrà riavere indietro il posto di lavoro. Le condizioni degradanti conseguono inesigibilità dei diritti connessa alla sperequazione dei rapporti di forza che la novella ha introdotto e generalizzato.
Ricordando che gli indici dello sfruttamento non devono essere tutti necessariamente sussistenti ma è necessaria la presenza anche di uno solo di essi, ebbene è autoevidente che in quasi tutti i rapporti
di lavoro al nero
precari ed autonomi (che nascondono in realtà rapporti di lavoro subordinato)
in appalto e subappalto
è facile rinvenire condizioni lavorative ed esistenziali rientranti nella fattispecie di reato in esame.
In tutti questi casi il datore di lavoro (e l’intermediario in caso di rapporto triangolare) rischia – se denunciato – una pena di reclusione sino a sei anni.