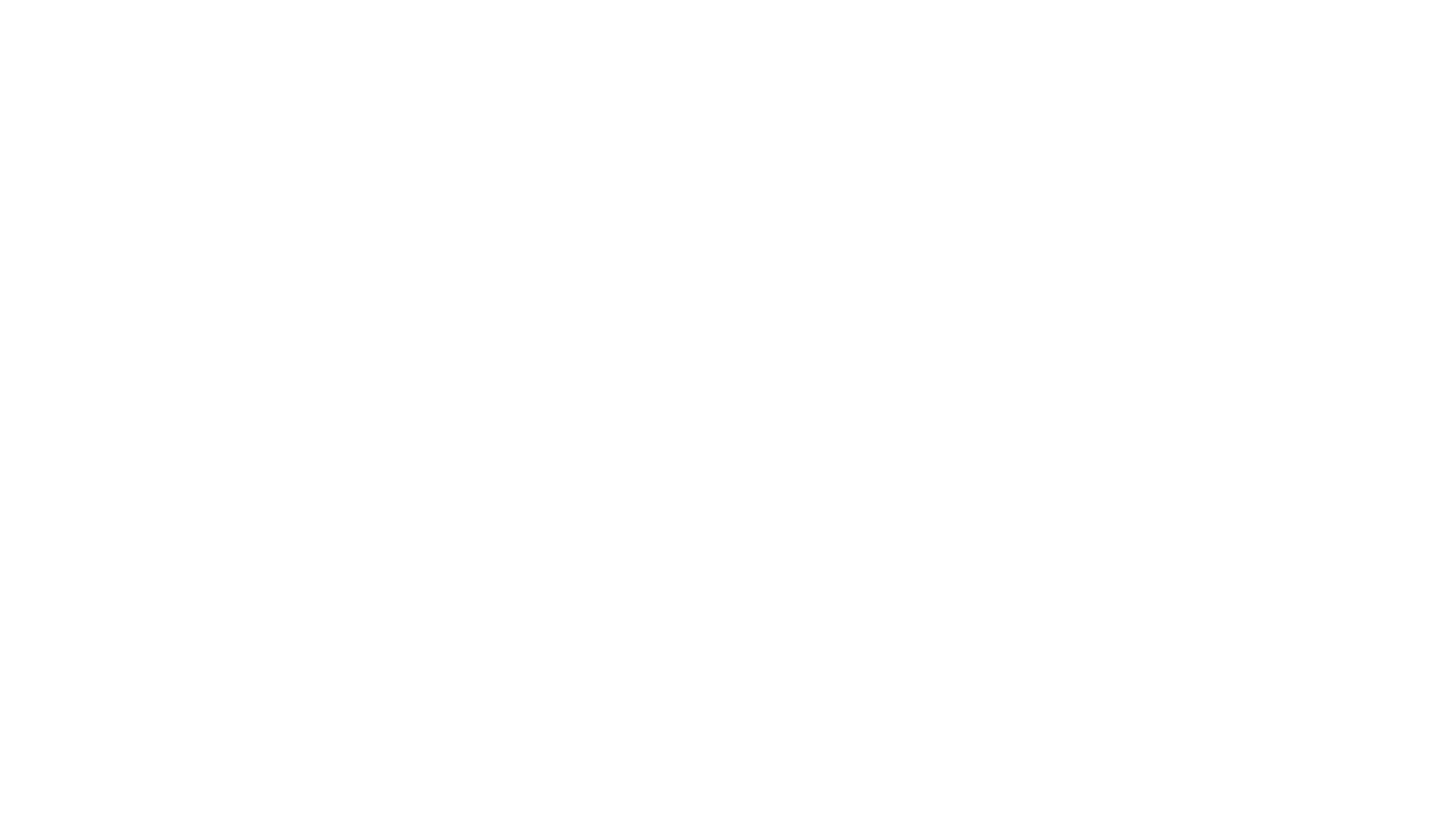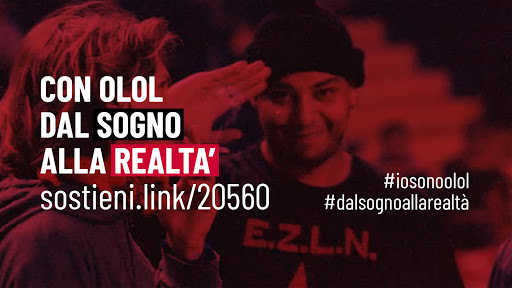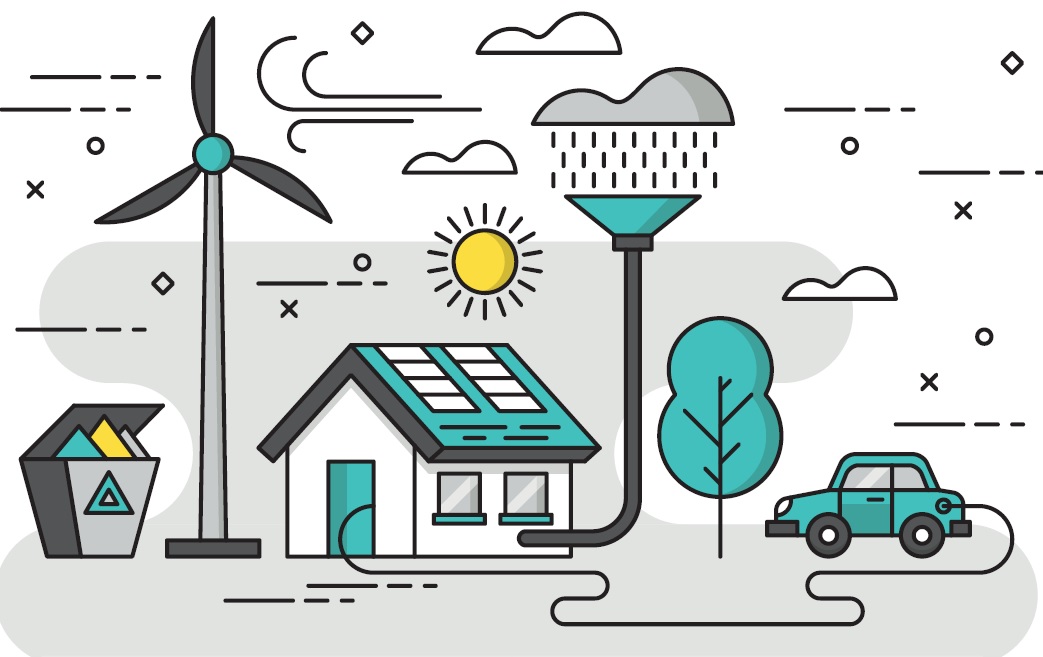Chi ha partecipato intensamente ai movimenti di lotta e di protesta degli anni 70 può portarsi dietro una serie di stereotipi che certe volte gli impediscono di capire i movimenti di oggi. Quello che succede in queste ore a Trieste non è immediatamente decifrabile, soprattutto per chi non è sul posto. Nessuno può negare però che tante categorie con cui si giudicano alcuni comportamenti di massa sono saltate ben prima dei fatti di Trieste, per cui l’esigenza di fare chiarezza è da tempo avvertita come urgente. Questo è un mio piccolo contributo alla chiarezza, maturato nei miei anni di studio e di docenza sulla storia del movimento operaio.
Vorrei parlare della categoria di «paternalismo».
Che cosa si è inteso con questo termine? (e non a caso uso il passato). Si è inteso un comportamento del datore di lavoro che offre ai suoi dipendenti un trattamento migliore di quello che avrebbero ottenuto o potrebbero ottenere mediante una tradizionale dialettica sindacale. Alla radice del paternalismo c’è sempre l’idea che il sindacato è superfluo. Questo si può tradurre anche nella costituzione in azienda di un sindacato «giallo». Il paternalismo è sempre di carattere conservatore e non va confuso con forme di politiche sociali del datore di lavoro che in realtà possono essere fortemente innovative. L’esperienza di Adriano Olivetti, per esempio, si può liquidarla come paternalismo? Penso proprio di no.
Ma il paternalismo è un fenomeno proprio di epoche in cui il sindacato è forte e rappresentativo, epoche in cui valgono i contratti nazionali e il datore di lavoro disposto a dare «un qualcosina in più» è uno che riconosce solo contratti aziendali. Non è la nostra epoca. Da noi i contratti nazionali valgono sempre meno, ce ne sono circa 900 registrati presso il Cnel, il sindacato della cosiddetta «triplice» Cgil, Cisl e Uil, vede costantemente erosa la sua presenza sui luoghi di lavoro, nel comparto della logistica rischia addirittura di essere minoranza, il proliferare di accordi aziendali è favorito dalla presenza dei Cobas. Ma soprattutto c’è un altro fattore di carattere strutturale che cambia i connotati del termine «paternalismo». L’Italia è fatta di aziendine piccole o microscopiche, di artigianato, dove per forza s’instaurano rapporti del tipo «siamo tutti una famiglia». Nel migliore dei casi. Perché sempre più frequente è la presenza di situazioni dove i più elementari diritti dei lavoratori sono negati, dove si verificano casi di schiavismo, l’Italia è il paese del subappalto, dell’outsourcing, del caporalato, anche in aziende solide (es. caso Grafiche Venete). Un imprenditore che paga i contributi rischia già di essere considerato «paternalista».
I porti e il caso di Trieste
In questo quadro s’inserisce il problema del porto di Trieste. Quando è arrivato alla presidenza Zeno D’Agostino la situazione del lavoro e in particolare del lavoro occasionale, a chiamata, nel porto di Trieste era la peggiore in Italia. Cooperative fallite, contenziosi a non finire, in una parola «il Far West», per dirla con una ricerca comparativa dell’Isfort su tutti i porti italiani. Per i concessionari dei terminal – diciamolo – avrebbe potuto benissimo continuare così. Invece Zeno D’Agostino, cogliendo al volo la possibilità legale di stabilizzare la forza lavoro offertagli dall’istituzione delle Agenzie del Lavoro da parte del Ministro Del Rio, ha ritenuto di poter porre fine a una situazione che produceva solo danni al porto di Trieste e che era molto simile a quella di migliaia di aziendine che campano eludendo in un modo o nell’altro il pagamento dei contributi e il riconoscimento dei più elementari diritti dei lavoratori. D’Agostino non ha «innovato» nulla, ha ristabilito la legalità. Ma nell’Italia di oggi è stata una scelta anomala, in particolare nel settore pubblico, così incline all’outsourcing.
Lo ha fatto perché «ha un debole» per i portuali? Lo ha fatto perché, come manager pubblico, ha il mandato di conservare e valorizzare un patrimonio dello Stato e ha capito che il modo migliore per farlo, per far crescere i traffici del porto, per attrarre investimenti, per accrescere l’occupazione, è quello di garantirsi una pace sociale ottenuta non attraverso contrattazioni sottobanco o favoritismi ma riconoscendo ai lavoratori i loro diritti fondametali. Nel caso specifico del lavoro portuale, limitando la precarietà.
Può essere definito questo «paternalismo»?
Certo, è stata una decisione presa «dall’alto», non è stata la conseguenza di una lotta di lavoratori con picchetti, ore di sciopero, veglie notturne, sacrifici di salario e magari conseguenze giudiziarie, come di solito avviene in questi casi, dove il diritto te lo devi conquistare con il sudore e il sangue. Come le lotte dei lavoratori dei magazzini della logistica – tanto per capirci – dove ci lasciano pure la pelle. È stata il risultato di una scelta «manageriale» che – particolare non secondario – si è rivelata giustissima.
Il Clpt (Collettivo dei Lavoratori del Porto di Trieste) continua a ricordare (a rinfacciare) a D’Agostino l’appoggio e la solidarietà che gli ha dimostrato quando una sciagurata sentenza di un’Authority romana lo aveva destituito. Quella è stata una bella pagina nella storia del Clpt ma credo che con quel gesto i lavoratori del porto difendevano anche se stessi e i diritti che la scelta manageriale di D’Agostino aveva loro concesso, non è che «si spendevano» generosamente per il loro Presidente. Certo, avrebbero potuto starsene a casa e non scendere in piazza, si sarebbero persi una splendida giornate di sole.
Poi le cose sono cambiate, i portuali hanno fatto diverse scelte sindacali, sono entrate in gioco altre dinamiche, in alcuni casi i terminalisti hanno cercato di ristabilire condizioni autoritarie, prontamente rintuzzate da una forza lavoro che ormai si era rafforzata nella solidarietà (ma anche da un deciso atteggiamento da parte della governance del porto), la decisione di Sommariva di accettare la nomina alla Presidenza di La Spezia ha fatto mancare un interlocutore con cui i portuali avevano una forte empatia. Il Clpt ha cominciato a essere riconosciuto come realtà cittadina e si è affrancato dalle pure logiche portuali, è diventato – possiamo dire – un attore della politica cittadina. Cambiando le cose, i rapporti con la Presidenza sono cambiati. Ma le cose sono cambiate così come sono cambiate in altri porti, si pensi a Genova, dove una parte dei portuali, per la prima volta dopo 70 anni (!), ha deciso di voltare le spalle alla Cgil. Questo non deve scandalizzare. Se si pensa alla drammatica situazione della formazione di ceto politico nell’Italia di oggi, al fatto che possiamo avere deputati semianalfabeti e Ministri con esperienza zero nella materia su cui dovrebbero governare – c’è da stare contenti che dei lavoratori del porto possano diventare non solo dei sindacalisti sul loro luogo di lavoro ma anche dei «cittadini che fanno politica».
Però nel momento stesso in cui lo diventano non possono pensare di sottrarsi al giudizio politico degli altri, non possono pensare che i loro comportamenti pubblici debbano sempre essere giudicati bonariamente solo come «azioni di un onesto lavoratore». In particolare oggi, dove con le problematiche sollevate dal Covid e dalla gestione governativa della pandemia, aggravata da micidiali tentennamenti dell’Oms, la complessità della situazione è aumentata a dismisura, la confusione delle lingue pure, la sistematica deformazione della realtà è un esercizio costante, lo spregio della competenza uno spettacolo televisivo. La complessità di oggi mette a dura prova il politico più «navigato», figuriamoci tutti gli altri, comprese «le matricole».
«No al Green Pass» come obiettivo unificante
Avevo scritto all’inizio che i reduci dei movimenti di protesta degli anni 70 possono portarsi dietro stereotipi e pregiudizi che impediscono loro di capire la realtà di oggi. È quello che è capitato anche a me. Quando a Trieste il coordinamento del movimento No Green Pass e il Clpt hanno dichiarato il blocco a oltranza del porto ho pensato subito a un’iniziativa neofascista. Trieste da questo punto di vista ha un ricco cv, non dimentichiamo che è stata la culla di Gladio, come ben ricostruisce Franzinelli nel suo volume sul 1960 e il governo Tambroni. Invece mi ero sbagliato di grosso (c’è da dire anche che manco da Trieste per ragioni di forza maggiore da almeno tre mesi, agosto compreso). Leggendo su www.infoaut.org la chiara cronistoria, scritta dai protagonisti, di quel movimento che ha visto alla fine migliaia di persone in piazza, ho capito che ero finito fuori strada. Il movimento l’avevano messo in piedi e gestito giovani che stanno nel campo opposto all’estrema destra.
Ma non per questo mi sono tranquillizzato, anzi, le perplessità sono aumentate e con esse gli interrogativi senza risposta. Ne riporto uno solo.
Trovo curioso che proprio sul porto si sia concentrata la protesta, cioè sulla realtà che bene o male funziona meglio. Non c’era proprio a Trieste e dintorni nessun altro simbolo dell’arroganza del potere o dello sfruttamento dei lavoratori da individuare come obiettivo? È proprio il porto la peggiore immagine dell’Italia di oggi? Tanto da mobilitare gente da tutta Italia e farla accorrere ai varchi? Qualcuno ricorda in Italia un fenomeno del genere per una lotta sindacale? Sì, il precedente c’è: la manifestazione del 18 settembre per la Gkn a Firenze. Ma quella era una manifestazione con l’appoggio della Cgil, di alcuni partiti. Qui sembra spontanea, una cosa a Trieste mai vista per una lotta sindacale in un luogo specifico di lavoro.
E allora il mio pensiero corre a un altro luogo di lavoro, che da lì, da dove c’è tutta quella gente, si vede a occhio nudo: la Fincantieri di Monfalcone, un’azienda pubblica – com’è pubblico un porto – dove il modello dell’organizzazione del lavoro è «leggermente» diverso, si basa sugli appalti e i subappalti, sul reclutamento di forza lavoro straniera proveniente da quegli ambienti che sono considerati l’ultimo girone dell’inferno del lavoro mondiale, dai cimiteri delle navi del Bangladesh. Un modello dove investigatori e magistratura hanno trovato anche corruzione e caporalati. Lì il sindacato ha firmato, proprio sugli appalti, a maggio di quest’anno, accordi che è meglio dimenticare.
Lì è tutto tranquillo, lì l’Amm. Delegato ing. Bono, può dichiarare alla stampa che assumerebbe volentieri migliaia di giovani italiani ma questi, purtroppo, preferiscono fare i rider…
In realtà il mio interrogativo rimane senza risposta perché parte da un equivoco: quello di considerare la vicenda triestina una lotta sindacale. Ma quella non è una lotta sindacale, come per Gkn, quella è una protesta politica contro la gestione governativa della pandemia e quindi concentra su un unico obiettivo simbolico – capitato per caso – non solo tutta la rabbia, le frustrazioni, le pulsioni che si sono accumulate in questo anno e mezzo, non solo la protesta studentesca, non solo i lavoratori con le loro famiglie, ma anche tutto il potenziale esplosivo del movimento no vax e la volontà dell’opposizione di Fratelli d’Italia e dei gruppi neonazi che hanno tutto l’interesse a destabilizzare il governo Draghi, sfidando apertamente l’ordine pubblico. Collante di tutto questo è stata la dichiarazione del blocco a oltranza che, dal punto di vista strettamente sindacale, quindi del solo Clpt, è un’idiozia, perché anche un bambino capisce che non avebbero potuto reggere più di un paio di giorni.
Se questo è vero, allora è anche plausibile che il movimento No Green Pass
a) sia stato generato a Trieste dall’area «antagonista» (detto per brevità),
b) quando è giunto al culmine dell’insperata mobilitazione i lavoratori del porto organizzati in Clpt ci sono saltati dentro e
c) invece di manifestare davanti alla Prefettura – simbolo dello Stato e del governo – sono andati a bloccare il porto e
d) lì hanno servito su un piatto d’argento un bel pranzo a chi non era invitato. A turisti di passaggio, a no vax militanti e neonazi.
Ma perché i portuali sono andati a cacciarsi in una situazione che poteva sfuggire al loro controllo? Non dobbiamo dimenticare varie cose: che il Green Pass è una questione che riguarda specificamente il lavoro e i luoghi di lavoro, che i sindacati di base della logistica avevano dichiarato sciopero generale il 15 ottobre e che la solidarietà dei cittadini con la protesta conto il Green Pass era stata massiccia. Alla fine però a Trieste sembrava che la partita si giocasse tra chi era disposto a concludere questo «tornante» di lotta (e magari riprenderlo più tardi o altrove) e chi pensava di poter continuare il blocco a oltranza rinforzando il picchetto operaio con la massa degli «autoinvitati».
Non era detto che dovesse finir male. Invece è finita con le cariche della polizia, ma i sostenitori del blocco a oltranza avrebbero dovuto saperlo sin dall’inizio che sarebbe finita così. Di mezzo qualcuno che «voleva» che finisse così ci deve essere stato. In questi frangenti la troppa ingenuità non è ammessa.
Io mi auguro solo che un ceto politico in embrione non perda l’entusiasmo ma sappia trarre l’insegnamento giusto da questa esperienza. Per questo su un punto vorrei essere chiaro e abbandonare per un momento le vesti di osservatore diversamente imparziale.
Il movimento no vax non puo’ che essere di estrema destra
Conosco bene i dilemmi del vaccinarsi o meno, li ho avuti in famiglia, con mio figlio, sebbene di lieve entità. Per questo distinguo tra il problema individuale e l’appartenenza, la militanza, al movimento mondiale no vax. Uno può essere operaio ma non per questo appartenere al movimento operaio. Considero l’idea di libertà del movimento no vax quanto di più contrario ci possa essere all’idea di solidarietà che sta alla base dell’esistenza stessa del movimento operaio, del sindacato, della sinistra. Ne ho scritto su un testo che circola su facebook e su diversi siti (tra cui https://www.officinaprimomaggio.eu/interventi/).
Quando è scoppiata la pandemia sono rimasto disorientato come tutti, l’unica voce era quella di un governo fatto di gente alle prime armi, del teatrino televisivo ne ho piene le scatole da tempo. Come orientarmi? Mi sono ricordato che di epidemie ne ho sentito parlare nel 1974-75 da gente che le ha studiate a fondo, da gente con cui ho lavorato, da uomini come Giulio Maccacaro, docente di statistica medica, direttore di Sapere, fondatore di Epidemiologia e Prevenzione, ispiratore di Medicina democratica e di quel movimento di lotta per la salute che ha svelato i danni dell’amianto e di tante altre sostanze tossiche letali o portatrici di malattie degenerative. Che ha anticipato i criteri fondatori del servizio sanitario nazionale, che ha combattuto Big Pharma e la ricerca asservita alle multinazionali, che si è battuto per una medicina territoriale e per una politica di prevenzione basata sulla consapevolezza dei cittadini, che ha pensato alla formazione degli operatori sanitari.
Tutto quello che la gestione governativa dell’emergenza non ci ha voluto o saputo dare. È una grande tradizione di conoscenza e di passione civile, è la «mia» cultura alla quale dovevo restare fedele. E questa diceva che la gestione dell’epidemia non si può limitare alle campagne vaccinali. È un problema assai più complesso che va affrontato con diverse strategie, in modo da indirizzare prima di tutto le persone verso un comportamento intelligente e consapevole. Anch’io ho avuto perplessità sul vaccino ma non sulla necessità di vaccinarsi e quando mi hanno detto «sei una cavia!» ho risposto che ne ero ben consapevole ma che la vaccinazione ha dato i suoi frutti lo dicevano i numeri. Con quel bel po’ di tradizione alle spalle avrei dovuto correre dietro ai vari guru no vax e andare a braccetto con quel tipo con le corna di bufalo che ha dato l’assalto a Capitol Hill? O con certi personaggi che in questo momento schiamazzano ai varchi del porto di Trieste?
No grazie.