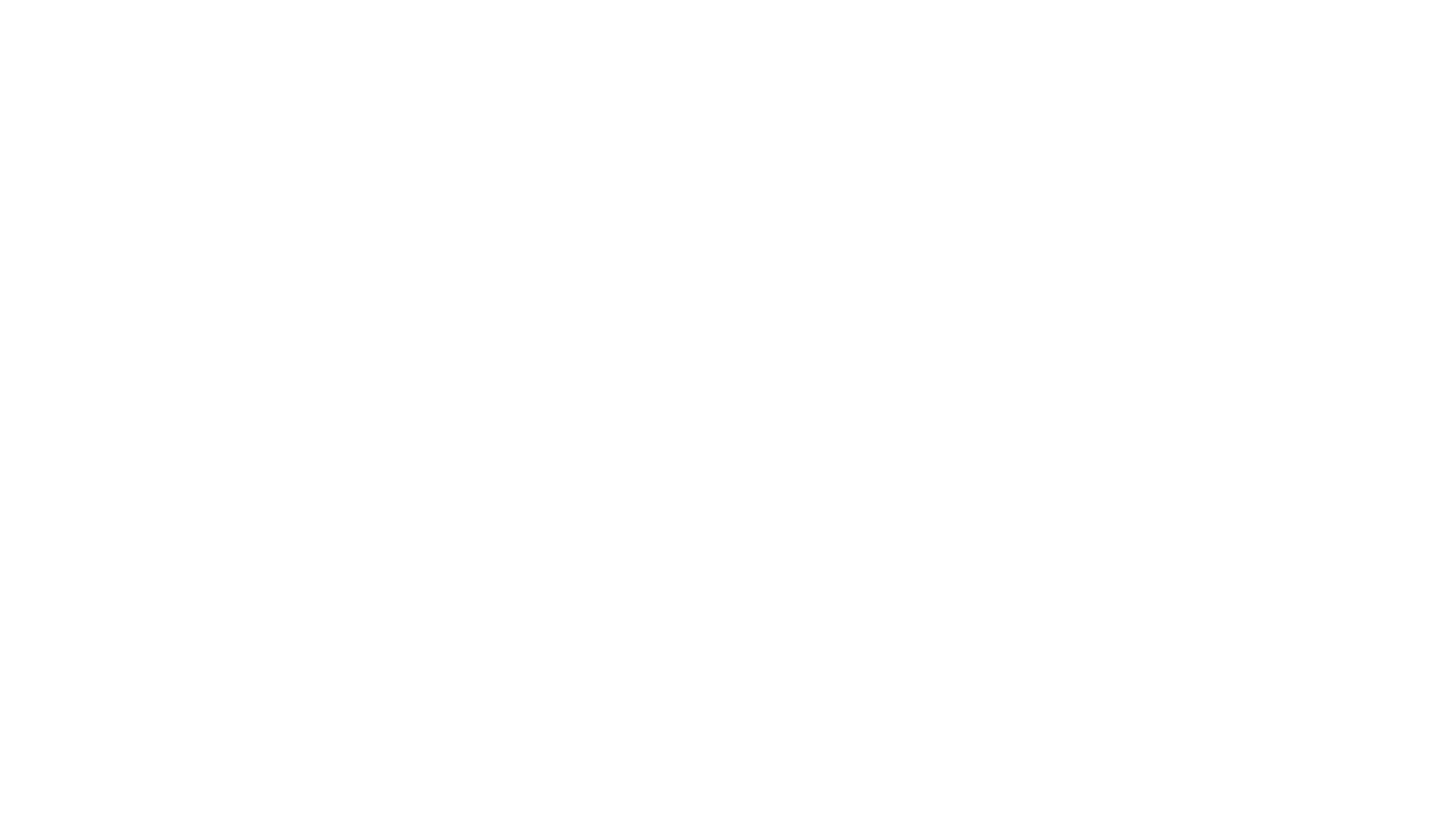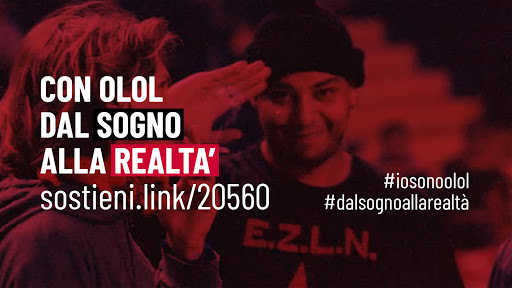Di Biagio Quattrocchi – CLAP ADL COBAS SIAL COBAS
Due documenti pubblicati a distanza di soli due giorni fotografano l’intollerabile crescita della disuguaglianza dei redditi, del basso livello dei salari e, più in generale, della povertà lavorativa in Italia. Guerra, ristrutturazione delle catene del valore tedesche e questione salariale sono tre aspetti inestricabili. È a questa altezza del problema che va ripresa la lotta sui salari, sul salario minimo legale, sul welfare e sulle forme della rappresentanza sindacale.
Il primo documento, che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, è stato il Rapporto mondiale sui salari (2024-25) curato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di Ginevra e presentato a Roma il 24 marzo. L’ennesima conferma della pesante «crisi salariale» italiana. Un testo che si aggiunge ad una lunga lista di studi di istituzioni internazionali e di statistiche ufficiali di cui oramai si è perso il conto. Negli ultimi diciassette anni i salari reali italiani hanno accumulato la contrazione più elevata nell’ambito dell’economie avanzate del G20, con una perdita pari a -8,7 punti percentuali. Nel quadro di un generale declino del potere di acquisto delle retribuzioni italiane nell’intero periodo, due sono stati gli intervalli più significativi.
Tra il 2009-2012, nel contesto della crisi finanziaria globale, in Italia la contrazione dei salari reali si è fatta sentire più che altrove. Sono gli anni, ricordiamolo, dell’«estremismo di centro» delle politiche neoliberali. Incombeva la crisi dei debiti sovrani nel cuore dell’Europa. Dopo la Grecia, l’Italia pagò il prezzo più alto delle politiche economiche austeritarie, sotto la spinta dell’allora ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, figura chiave dello Schwarze Null (pareggio di bilancio). Assurto dogmaticamente a «legge aurea» sin dall’inizio della svolta neoliberale, questo approccio di politica economica in realtà ha contribuito per un lungo periodo ad assicurare all’economia tedesca una funzione di traino fondata sulle esportazioni di merci, favorendo indirettamente sentieri salariali divergenti all’interno del vecchio continente. Blocco del turn-over e della contrattazione nella P.A., ricorso all’esternalizzazione di servizi mediante appalti, nuove regole della contrattazione collettiva nel privato con l’Accordo interconfederale del 2009 – solo per fare tre esempi – hanno profondamente contribuito ad accentuare la contrazione dei salari reali nel nostro paese. Il secondo e più recente intervallo, tra il 2022 e il 2023, è segnato dalla crisi inflattiva che ha picchiato particolarmente duro sulle retribuzioni italiane, in un contesto già dominato da insopportabili ritardi nei rinnovi contrattuali (a fine dicembre 2024 secondo Istat la metà dei dipendenti privati aveva ancora un contratto collettivo scaduto). La questione, come mostrato da diversi studi, è che l’inflazione del biennio ha scatenato in Italia la più rapida distruzione del salario reale dal secondo dopoguerra.
Forse isolati questi due intervalli, che guarda caso coincidono con due momenti di crisi, è più facile comprendere che la «questione salariale» italiana non si può affrontare con le pennellate dei tagli del cuneo fiscale come sostiene il governo Meloni, perché è un aspetto strutturale alle trasformazioni capitalistiche in atto, che dalla crisi dei sub-prime del 2007 arrivano fino all’attuale regime di guerra globale.
Cosa è accaduto più o meno nello stesso periodo alle imprese? Secondo l’ultimo rapporto Le medie imprese industriali italiane di Mediobanca – il presunto fiore all’occhiello del capitalismo italiano, quello delle aziende leader dei distretti, il motore del cosiddetto made in Italy, coccolato dall’attuale destra reazionaria come dai passati governi di centro-sinistra –, tra il 2013 e il 2022, il valore aggiunto prodotto è cresciuto del 47,3%, mentre il margine operativo netto (in altri termini i profitti) è aumentato del 96,8%.
Cos’è questo? Mero conflitto distributivo? Remunerazione del rischio d’impresa? No. È l’espressione violenta di una «guerra di classe» agita senza sosta. Solo che questo, come ricorda spesso Sergio Bologna, è il volto più «pulito» di questa guerra. La parte «sporca», per così dire, sta nel sistema di appalti e subappalti della logistica, nelle piccole aziende del terziario avanzato che pretendono alte competenze senza assicurare una retribuzione, nei comparti del lavoro di cura più precarizzati, nel riemergere del lavoro neo-servile in agricoltura. A queste, poi, si aggiunge anche una terza parte, diciamo più «invisibile», che sta nell’esplosione di lavoro non retribuito fuori l’orario di lavoro, fuori dai contratti standard, così come nelle pieghe della stessa prestazione di lavoro dipendente apparentemente tutelata, come il lavoro delle insegnanti o in altri settori della riproduzione sociale o del terziario.
Il 26 marzo l’Istat ha pubblicato il report sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie relativo al biennio 2023-24. Da anni assistiamo ad una polarizzazione della distribuzione dei redditi, in cui strati sempre più consistenti del «ceto medio» sperimentano uno scivolamento verso il basso. Il più delle volte lentamente, talvolta repentinamente, ingenerando un senso di frustrazione rancorosa i cui tratti sono visibili anche nelle espressioni di voto alla destra post-fascista. Altri, invece, a dire il vero una parte assai più esigua, si attesta verso livelli più alti della distribuzione del reddito, trovando riparo tra i working rich.
Via via che il «ceto medio» si scompone, subiamo lentamente un’inesorabile crescita dell’area di lavoratrici e lavoratori a basso reddito. Nel 2023 la forza lavoro a basso reddito risulta pari al 21% del totale, così ci dice l’Istat. Il rischio è più alto per le donne (26,6%), a fronte di quello degli uomini (16,8%). Ancor più preoccupante è che dal 2007 al 2023 la quota di lavoratrici e lavoratori a basso reddito risulta incrementata di ben 4 punti percentuali. A crescere è anche la quota dei working poor che passa dal 9,9% nel 2023 al 10,3% nell’anno successivo, mentre risulta nello stesso anno che poco meno di 1 migrante su 4 è un lavoratore o lavoratrice povero/a (22,6%).
È oramai indiscutibile che la crisi salariale italiana ha conosciuto una accelerazione a partire dai primi anni Novanta. Ciò avveniva in prossimità della crisi valutaria del 1992 che preparò la strada alla riforma di Maastricht, ma soprattutto, come conseguenza della nuova regolazione delle relazioni industriali avviata nel biennio 1992-93, da cui ancora oggi deriva gran parte dell’intelaiatura del nostro sistema di contrattazione collettiva. Come noto sono gli anni in cui prende corpo il «sindacato della concertazione». Le organizzazioni confederali accettarono la moderazione salariale in cambio di un ruolo nelle scelte di politica economica. Ruolo che è durato per una brevissima congiuntura o, in realtà, come era prevedibile, non è mai stato pienamente concesso. I risultati di quella miope, nefasta e disgraziata strategia sono oggi pienamente evidenti.
Philippe Schmitter è un politologo americano a cui si deve, già nel lontano 1974, il fatto di aver coniato il termine neocorpativismo. Un sistema di regolazione degli interessi tra capitale e lavoro, in cui grandi organizzazioni del lavoro “particolarmente rappresentative” siedono con le imprese e lo Stato per mitigare e ricomporre il conflitto sul terreno delle riforme e stabilire comunamente strategie di politica economica. Ovvero: una delle più grandi e pie illusioni socialdemocratiche sviluppate in risposta al ciclo di lotte degli anni Settanta. Bisogna tornare qui per capire da dove deriva la «crisi salariale», altrimenti si rischia di non capire.
Quando prendeva forma il neocorporativismo in salsa italiana, all’inizio degli anni Novanta, si assisteva al massiccio ricorso all’esternalizzazione dei servizi pubblici, iniziavano ad essere introdotti i primi criteri ispirati al New Public Management che hanno portato ad una nuova organizzazione del lavoro pubblico, si introduce l’autonomia scolastica, si sperimentava l’accelerazione della scomposizione della grande fabbrica e il consolidamento dei distretti industriali, la tecnologia dell’ICT si diffondeva velocemente, cresceva il numero dei cosiddetti lavoratori autonomi di seconda generazione.
Il fatto che oggi si ammetta che la «concertazione» è in crisi, non è solo perché il governo Meloni è particolarmente più autoritario. Il punto di fondo è che quel sistema è in crisi perché ha concluso il suo ruolo. Il sistema materiale su cui si reggeva non esiste più. Il rischio è proprio che nel nuovo contesto della guerra e della ristrutturazione delle catene del valore tedesche possa prendere forma una variante del modello neocorporativo ancora peggiore.
È per questa ragione che diventa essenziale battersi per un aumento dei salari, per l’introduzione di un salario minimo legale e, contemporaneamente, per un allargamento delle libertà e dell’agibilità sindacale contro ogni chiusura neocorporativa.