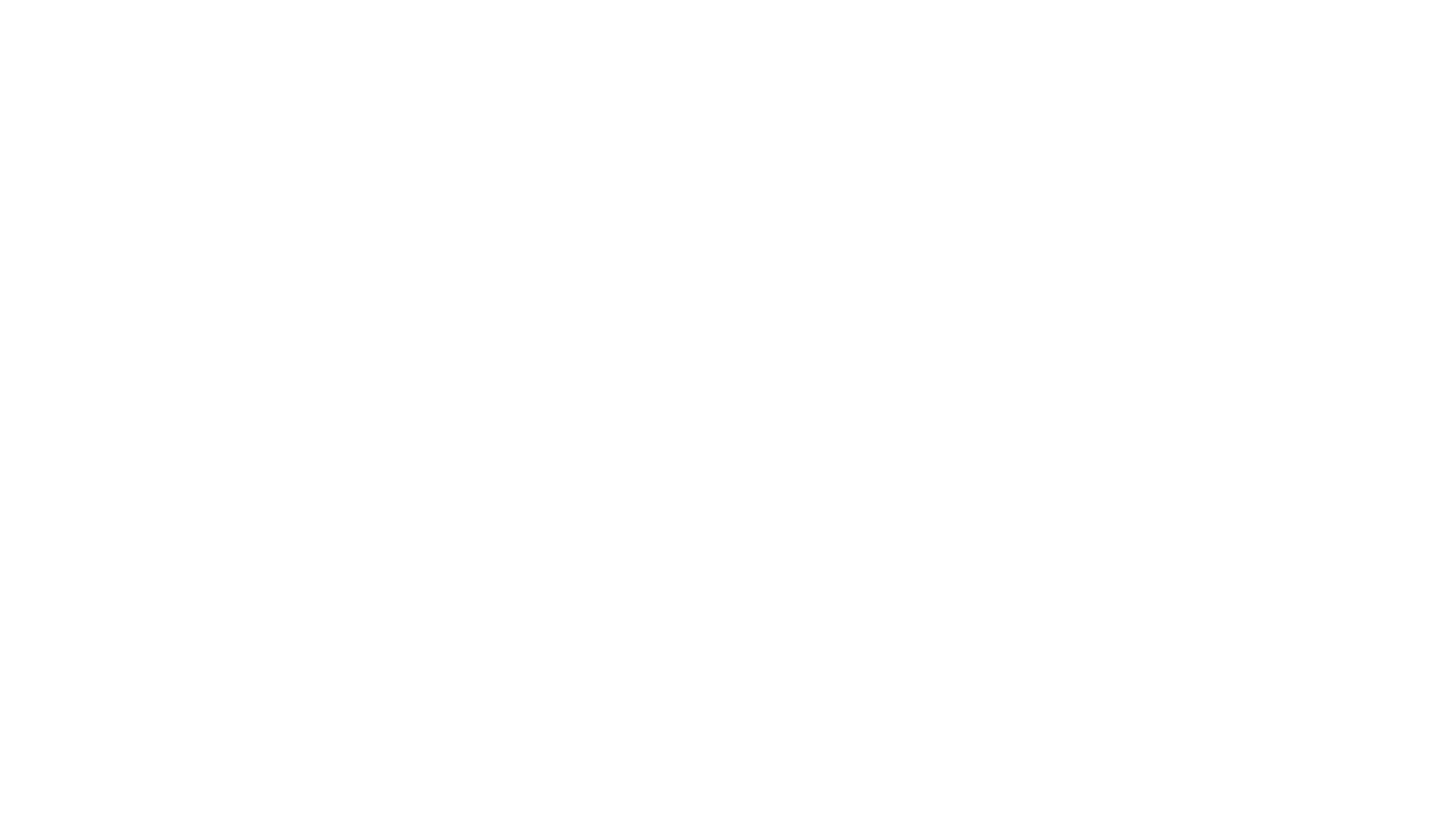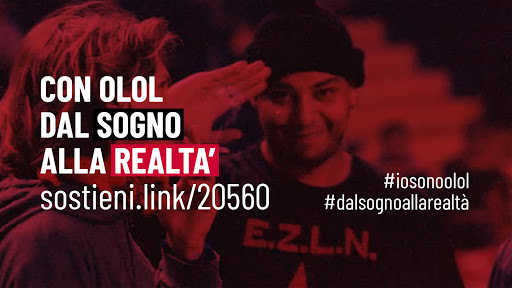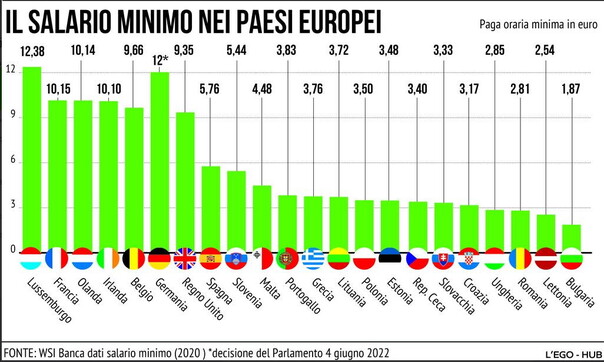Stefano Cucchi, romano, 31 anni, un passato da tossicodipendente, viene arrestato dai Carabinieri nell’ottobre 2009 mentre porta a passeggio il suo cane: l’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ oggetto di un pesante pestaggio in caserma. Dopo una settimana muore all’ospedale Pertini. La famiglia e i movimenti riescono a spezzare il muro di omertà che circonda questa ennesima morte di Stato costringendo l’avvio di un’inchiesta giudiziaria. Il pubblico ministero accusa tre agenti della polizia penitenziaria di aver percosso Stefano fino a cagionare lesioni gravissime, tre infermieri e sei medici di falso e abbandono. La vicenda rilancia subito la necessità di porre limiti precisi all’uso della forza da parte delle nostre quattro polizie, di normare le operazioni di fermo in ordine alle modalità e le garanzie dei diritti del fermato – primo tra tutti quello di non finire ammazzato di botte – di introdurre nel nostro ordinamento penale il reato di tortura, così come prescritto da un’antica risoluzione ONU. Molte ed eterogenee le voci che indicano questo orizzonte.
A fine 2012 viene resa nota la perizia disposta dalla terza Corte di Assise di Roma per accertare le cause del decesso. Le conclusioni dei sei professori dell’istituto Labanof di Milano dicono che Stefano morì per colpa dei medici, i quali sottovalutarono la carenza di cibo e di liquidi, il suo grave stato di malnutrizione. Spendono 190 pagine per mettere in dubbio la relazione tra morte e pestaggio. Le fratture alla schiena potrebbero essere il risultato forse di un’aggressione, forse di una caduta a terra: “non vi sono elementi che facciano propendere per l’una piuttosto che per l’altra dinamica lesiva”. Imperizia, negligenza, superficialità, omissioni: una condotta semplicemente “colposa”. Attuata sul corpo di un ragazzo malato che chiedeva di un avvocato per denunciare i fatti e che invece non ha potuto incontrare nemmeno i familiari. Servono dei professori di rango per garantire in via preventiva l’assoluzione degli agenti e di tutto il sistema che favorisce la loro impunità.
Nell’aula bunker di Rebibbia a giugno 2013 la terza Corte di Assise di Roma emette la sentenza per i tre agenti della polizia penitenziaria, i tre infermieri e i sei medici dell’ospedale Pertini: fino a un massimo di due anni per i soli medici, per il reato di omicidio colposo. Pene interamente paralizzate tramite l’applicazione della condizionale. Non assassinio dunque ma incuria, trascuratezza professionale, errori, omissioni. Nessun pestaggio. La vita di Stefano vale 320 mila euro, a tanto ammonta la provvisionale disposta in via accessoria. La Corte fa suo il contenuto inverosimile della perizia malgrado le immagini del corpo martoriato siano da anni di dominio pubblico, apponendo un altro sigillo a quel pacchetto di norme non scritte che consente ai nostri quattro corpi di polizia l’uso impunito della forza: “consuetudine” risaputa, tollerata, rivendicata. Dalla “macelleria messicana” della scuola Diaz di Genova 2001 passando per gli omicidi Aldrovandi, Uva e purtroppo molti altri si stende attorno alla famiglia Cucchi una rete sempre più ampia di solidarietà e collaborazione. Perchè lo sappiamo tutti che ad ammazzarlo di botte sono stati i carabinieri. Ce lo racconterà addirittura un bel film del 2018.
Eppure la politica e le istituzioni hanno finto di non saperlo, di non vedere il muro di omertà edificato a protezione della catena di comando di quell’arma dei Carabinieri che dopo quasi dieci anni di falsificazioni, ricatti, bugie, abusi e depistaggi oggi ha la sfacciataggine di dichiarare di volersi costituire parte civile contro i colpevoli. Che non sono solo gli artefici materiali del pestaggio, ma tutti coloro che hanno operato per negarlo. E sono molti. Ora la testimonianza del vicebrigadiere Francesco Tedesco, testimone oculare, deve essere letta non solo come disvelamento di un omicidio in ordine al quale nessun dubbio era ormai legittimo, ma soprattutto come messa in evidenza della copertura istituzionalizzata che scatta in automatico per occultare le violenze poliziesche, per nascondere le prevaricazioni, per garantire salvacondotti giudiziari a tutti coloro che agiscono per via gerarchica. Della distorsione inscritta in quello “spirito di corpo” che serve a coprire sistematicamente i colpevoli, a istituzionalizzare il clima di connivenza, a normalizzare l’occultamento delle responsabilità.
Da una parte il Potere, dall’altra il Diverso: i calci in faccia sono la normalità di questa relazione, questa è la regola. Questa svolta processuale consente di rimettere a valore la pratica dei diritti dei cittadini e dei doveri delle forze dell’ordine. Di indicare con forza lo Stato quale mandante di questo omicidio, quale responsabile di una sospensione della democrazia che ha le sue radici nelle giornate di Genova, quale artefice di un’ opposizione alla giustizia che una famiglia caparbia, una sorella coraggiosa, un avvocato irriducibile e tutti coloro che li hanno sostenuti hanno saputo spezzare. Può riportare con decisione l’agire dei movimenti sul terreno del contrasto alla pratica criminale della forza poliziesca, della determinazione di norme certe sull’uso delle armi, sulle regole di ingaggio, sulla riconoscibilità del personale in divisa. E, ancora una volta, sull’introduzione di norme penali credibili e attualizzate che regolino il reato di tortura.
La verità storica sull’omicidio di Stefano la conosciamo da tempo, la verità processuale deve ancora essere ratificata. L’esperienza ci insegna che spesso, troppo spesso, le due cose non coincidono: restiamo sintonizzati.