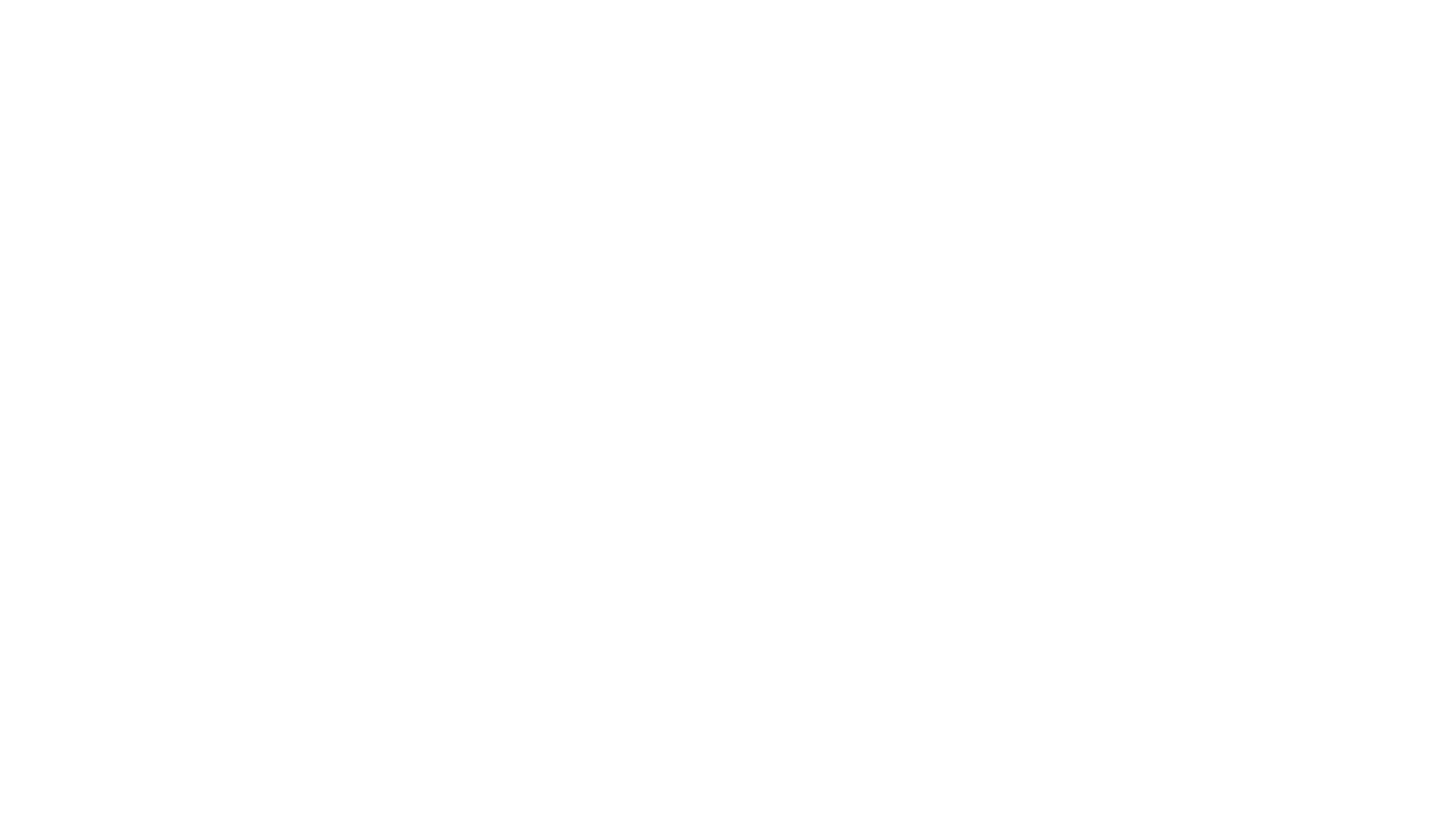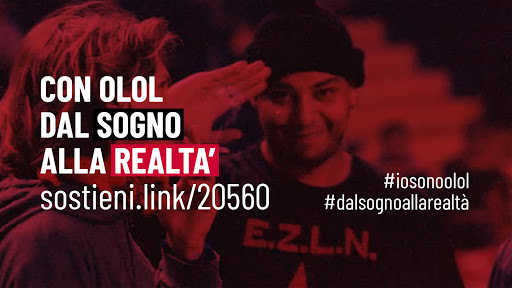Il 18 e 19 febbraio è stato raggiunto un accordo tra i paesi membri della UE che sconvolge i principi di base della libera circolazione e delle protezioni sociali dei lavoratori migranti interni.
L’accordo è stato raggiunto alla fine di un lungo negoziato allo scopo di convincere il primo ministro britannico, David Cameron, e il suo governo a sostenere la campagna per il SI (rimanere) in vista del referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea che si terrà il 23 giungo 2016. Referendum promosso dallo stesso Cameron, salito al governo strumentalizzando il clima anti-immigrazione reso incandescente dal rafforzamento di partiti anti-UE populisti e xenofobi come UKIP (Il Partito per l’Indipendenza del Regno Unito) e sotto gli effetti dell’austerity.
Le concessioni fatte al Regno Unito hanno una valenza tale da mettere in discussione l’intero impianto di coordinamento della sicurezza sociale in Europa per i lavoratori e le lavoratrici migranti. Si tratta quindi di un accordo che riguarda tutti i paesi membri e non solo la Gran Bretagna.
L’accordo prevede che qualsiasi membro dell’Unione che dimostrerà di trovarsi in una “situazione di afflusso di lavoratori provenienti da altri Stati membri di portata eccezionale” al punto tale da “ledere aspetti essenziali del suo sistema di previdenza sociale” potrà restringere i diritti sociali di natura non-contributiva collegati all’esercizio di un’attività lavorativa dei lavoratori mobili cittadini dell’UE, come ad esempio le integrazioni salariali previste in Gran Bretagna per i lavoratori a basso reddito. Tale sospensione emergenziale del principio di parità di trattamento dei cittadini dell’UE è concessa per un massimo di sette anni e si applicherà a tutti i nuovi arrivati per un periodo massimo di quattro anni dalla data d’inizio del rapporto di lavoro.
Uno degli assunti ideologici alla base di tale accordo è che i e le migranti che accedono a questo tipo di benefici “approfitterebbero” della relativa “generosità” del sistema di welfare del paese ospite il quale rappresenterebbe un fattore di attrazione nella scelta del paese di emigrazione. Se da un lato potremmo anche considerare ragionevole il fatto che il sistema sociale di un paese costituisca uno degli aspetti che i e le migranti (più che legittimamente!) prendono in considerazione quando si muovono, per combattere la ‘mitologia’ del turismo sociale forse ciò che è più utile smascherare è che, la popolazione “straniera” in realtà è in credito rispetto ai sistemi di welfare dei paesi ospitanti. In tutti i paesi OCSE (Rapporto OCSE 2013 sulle migrazioni internazionali) i migranti versano più in termini di contributi sociali e fiscali di quanto ricevano tramite le prestazioni sociali. Questo è un dato particolarmente evidente in paesi di recente immigrazione come l’Italia. Secondo le elaborazioni delle Fondazione Leone Moressa su dati del Ministero delle Finanze e dell’Istat, nel 2012 le entrate nelle casse dello Stato italiano provenienti dai migranti (UE e non-UE) sotto forma di tasse e contributi hanno superato di 3,9 miliardi le uscite in termin di spesa pubblica per l’immigrazione (sanità, scuola, servizi sociali, casa, trasferimenti economici, contrasto all’immigrazione irregolare).
L’accordo prevede, inoltre, la modifica del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per rendere applicabile un altro dei ‘compromessi’ chiave raggiunti a Bruxelles e cioè quello che riguarda le prestazioni sociali per i figli a carico che risiedono in un paese diverso da quello dove soggiorna e lavora il o la migrante. La proposta è di “indicizzare” tali prestazioni secondo il costo della vita del paese di residenza dei figli a carico, cosicché per esempio gli assegni familiari non rispecchieranno l’importo versato dal/lla migrante quanto a contributi e fisco (questi ovviamente non hanno sconti rispetto a quelli versati dai ‘normali’ lavoratori nazionali).
E’ importante sottolineare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva già espresso parere negativo di fronte al tentativo di alcuni Stati di restringere l’eguaglianza di accesso a questo tipo di benefici per i lavoratori migranti e le loro famiglie. Nei suoi giudizi la Corte si era appellata all’Articolo 7 del regolamento UE 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori, che stabilisce che ogni migrante interno “gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali”. Questo principio è infatti alla base della libera circolazione dei lavoratori che, insieme a quella di servizi e merci, hanno finora rappresentato il tratto unico del mercato comune UE rispetto a quello globale, dove i confini continuano e sempre di più a “fare” la differenza in una selezione sempre più feroce e classista tra i migranti “buoni” e “cattivi”, altamente o poco-qualificati, utili o meno all’economia nazionale.
Ciononostante, sebbene l’Unione Europea venga rappresentata come uno spazio senza frontiere all’interno del quale i cittadini possono muoversi liberamente, è bene ricordare che in realtà è un campo attraversato da multipli confini interni volti ad ostacolare la mobilità dei più poveri. L’attuale normativa in materia di libera circolazione è infatti il risultato di un conflitto storico tra paesi esportatori e importatori di manodopera: i primi promotori del principio della parità di trattamento dei lavoratori (diritti sociali inclusi) e i secondi fautori dell’introduzione di limiti alla libera circolazione, per mantenere bassi i costi della forza lavoro straniera e contenere la spesa sociale. Ecco perché il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nell’affermare e regolamentare la libertà di circolazione e di soggiorno, stabilisce anche i suoi limiti. Innanzitutto, il diritto dei lavoratori di circolare liberamente può essere limitato da questioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica e questioni di interesse pubblico come il contrasto della disoccupazione o la difesa del sistema nazionale di previdenza sociale. In secondo luogo, la libertà di soggiorno in un paese membro è riconosciuta a una categoria limitata di cittadini, ossia i soggetti economicamente attivi, mentre è subordinata al means test (accertamento delle condizioni economiche) per le persone non occupate o inattive, per assicurarsi che non costituiscano un “peso” per lo stato sociale del paese accogliente, poiché non avendo contribuito alla ricchezza del paese in cui soggiornano si ritiene che esse non possano aspirare ai benefici sociali che lo Stato garantisce ai propri cittadini. E’ proprio a queste possibilità di restringere la libertà di circolazione e di soggiorno dei lavoratori e più in generale dei cittadini dell’Unione Europea, contemplata dai trattati, che si è appellato il Consiglio Europeo per soddisfare le richieste britanniche.
Gli accordi tra UE a Gran Bretagna sono l’ennesimo tentativo di scalfire il principio della parità di trattamento degli individui e di restringere la libertà di movimento all’interno dello spazio europeo. L’obiettivo è quello di indebolire il potere di negoziazione dei migranti interni e renderli sempre più ricattabili e dipendenti dal lavoro a qualsiasi condizione e con qualsiasi salario. A fronte di una diffusione di lavori mal pagati e precari proprio tra i lavoratori e le lavoratrici che arrivano nel Regno Unito dai paesi più poveri dell’Unione Europea, dell’est come del sud, è facile immaginare quali saranno gli effetti delle restrizioni all’accesso ai sussidi di integrazione del reddito sul potere contrattuale dei lavoratori nel mercato del lavoro e sul posto di lavoro. Per quanto i e le migranti di cittadinanza europea abbiano finora subito condizioni di lavoro di maggiore sfruttamento rispetto ai cittadini britannici, per via della loro conoscenza limitata della lingua e dei diritti, ma anche di una maggiore dipendenza dal reddito da lavoro, crediamo che tali restrizioni dei diritti sociali possano avere un grave impatto sulle condizioni di lavoro di tutti e tutte, perché stratificano ulteriormente la classe operaia inglese ed europea.