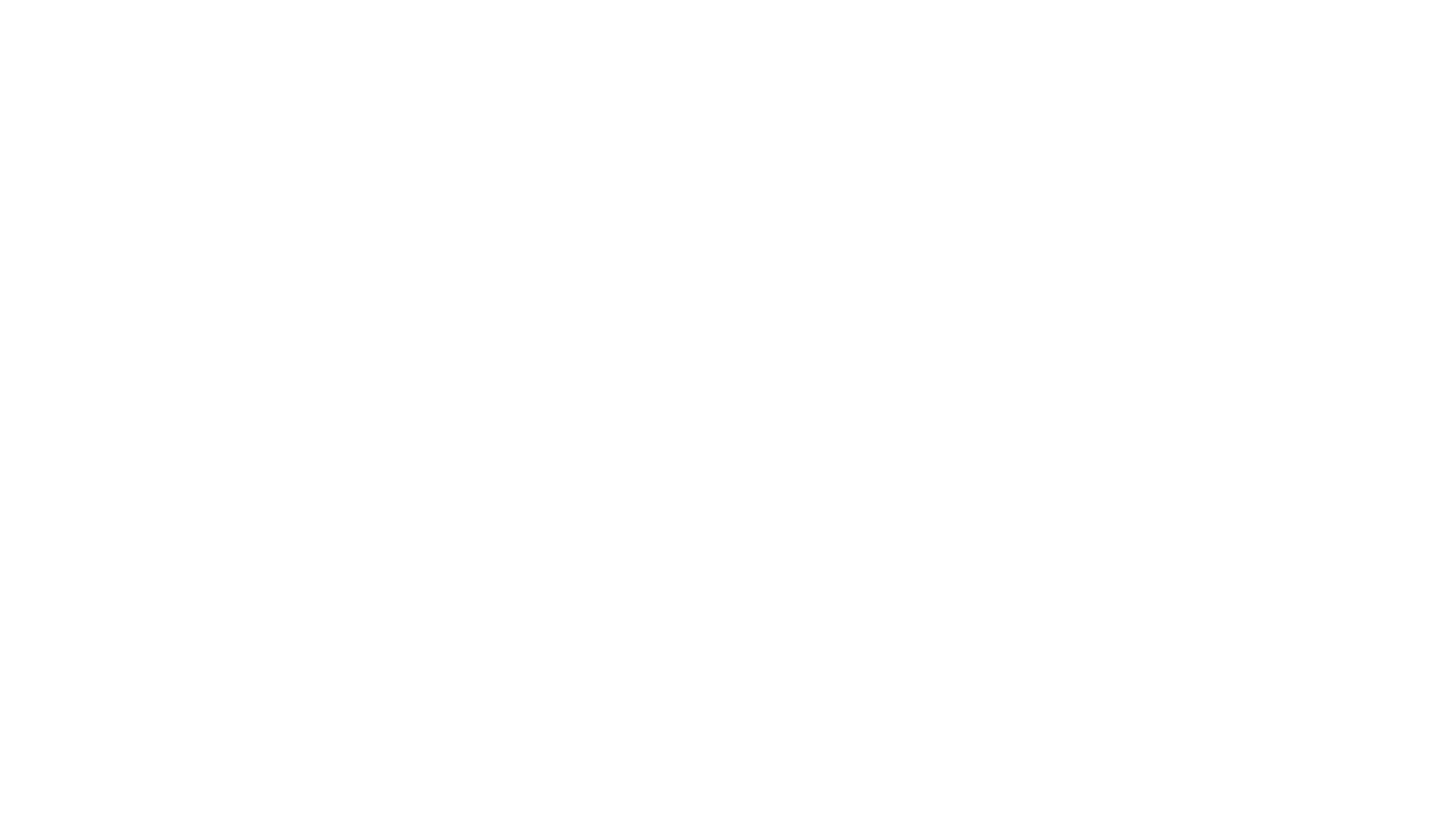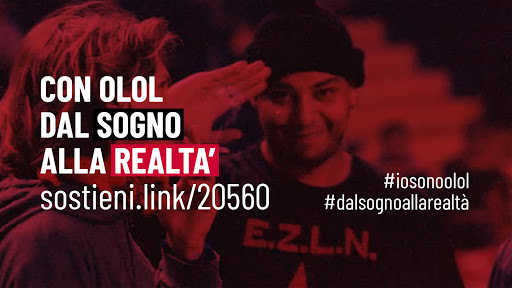novembre 1998, un lunedì
La nebbia avvolge ogni cosa, sembra un velo steso davanti agli occhi a confondere le linee del paesaggio.
La serata è umida, la pioggerellina sottile impregna ugualmente gli abiti.
La bici scivola sull’asfalto bagnato cercando di evitare le buche gonfie di acqua limacciosa.
La luce dei lampioni sembra compressa come l’aria pesante della sera, il riverbero disegna il profilo delle
mura medioevali della città mentre di fronte una lunga inferriata difende il blocco della questura. Due
transenne davanti all’ingresso gocciolano ai piedi della lugubre insegna mentre lo sguardo si posa su
quella luce accesa al quarto piano: la legge non chiude gli occhi neanche alle nove di sera.
Dopo la svolta ci s’immerge in un quartiere asettico, figlio di una pianificazione urbana scellerata e
marcato dalla presenza delle banche che ne hanno ormai definito il nome. Sedi d’istituti di credito
circondate da piattaforme, passaggi e rampe in un dedalo sopraelevato dalla strada. Qui il solo rumore era
lo stridore delle ruote degli skate che perturbavano l’arredo urbano aprendo effimere piste tra il cemento.
I sedici anni fanno coesistere slanci talvolta incoscienti verso l’ignoto e timori di non essere all’altezza.
Quella sera il ragazzo appoggia la bici a pochi metri dalla facciata da Gotham City della banca
impopolare della città, accanto alle tiepide luci verdi della birreria di Lello incastonata nei palazzi freddi.
Attraversa la strada per varcare la porticina che si chiude a molla ed entra nello stanzone sfilando sotto la
grande scritta “centro sociale Ya Basta!” sulla facciata.
Ci è già stato qualche volta, ai concerti, affacciandosi in un mondo sconosciuto, diverso, che palpitava di
energia. Qualcuno avrebbe storto il naso nel vedere le tante lattine accartocciate di Moretti e annusare gli
sbuffi di cannoni, ma lui ci vedeva libertà e leggeva nei manifesti alle pareti una parola, autonomia, che
iniziava a riecheggiargli dentro.
Quella sera andava alla sua prima assemblea di gestione, e se arrivi puntuale vuol dire proprio che non sai
come funziona. Il posto sembra deserto, il silenzio è rotto dal ticchettio dei tasti del computer. Uno
schermo, una tastiera e una torre troneggiano in un angolo, accanto a scatoloni dell’archivio e sotto gli
striscioni appesi alle pareti scrostate.
Nello stanzone fa freddo e lo vede di spalle seduto al tavolino, indossa anche al chiuso il bomber verde
sopra la felpa col cappuccio, la malboro rossa si spegne lentamente tra le sue dita mentre scorre le notizie
delle prime mailinglist nazionali, su ecn.org
Chi è dietro lo schermo in quel posto è da parecchio che ci è entrato… anzi è uno di quelli che già quattro
anni prima l’aveva aperto, occupandolo per scuotere il grigiore della città berica feudo DC.
Olol stringe la mano e apre un sorriso al ragazzo che dopo qualche istante di silenzio comincia una
sequenza di domande, spesso stupide. Parla tanto il bocia eh! e all’osservazione è seguito, come spesso
avveniva, l’attribuzione di un nomignolo ad indicarlo.
L’atmosfera è intrisa dal fumo delle sigarette che circonda il piccolo cerchio di sedie al centro della
stanza. Discussione, intervento, volantini, manifesti, colla, attacchinare, servizio d’ordine, cordone…
nuovo lessico, nuovi modi di fare le cose e immaginare una forza collettiva a partire dalla dozzina di
compagni e compagne in cerchio.
Quella sera non ricordo di cosa si parlava ma so che l’intervento più incisivo lo facesti tu. La parlata
diretta, le frasi decise, mi scoprivo a seguire un pensiero chiaro accompagnato da proposte concrete per
2
l’indomani. Il tutto chiuso dalla frase ad effetto, poi la battuta e la risata contagiosa. Ascoltando,
iniziavo a imparare e capire come si vive un movimento, senza vincoli né padroni, autonomo insomma.
L’indomani saresti dovuto andare, come sempre, in fabbrica, nella anonima zona industriale ovest.
Non era una festa andarci ogni mattina in fabbrica, e così, da liceale sbarbato, sentivo i racconti, i lamenti
oltre alla voglia e la determinazione di non regalare nulla ai padroni, a partire dalle piccole cose.
febbraio 2016, venerdì
Il freddo fa stringere le spalle e le nuvolette di fumo accompagnano i respiri e le parole del picchetto.
È un’altra alba, un’altra fabbrica, sono passarti quasi vent’anni…
Il deposito è nel paese alla metà tra Vicenza e Padova, lungo quella metropoli diffusa dove le zone
artigianali delle località distinte si toccano e agli alti campanili la legge Tremonti ha affiancato capannoni
di cemento.
La fabbrica questa volta è un deposito, dove dozzine di camion prelevano bancali di merci per i
supermercati della regione assicurando il ciclo continuo delle offerte discount.
La fabbrica è il posto dove decine di facchini lavorano giorno dopo giorno, con orari labili e retribuzioni
risibili. Ma anche quel posto dove per guadagnare ancora dallo sfruttamento altrui, sponsorizzati dalle
riforme legislative e benedetti dai confederali, si arriva a licenziare di punto in bianco.
La fabbrica non è un moloch inarrestabile, la determinazione può fermarla: con i picchetti si blocca la
produzione, la dignità la difendono quelli ai cancelli con i cartelli e i berretti ben calcati sulla nuca. Un
fuoco di bancali scoppietta cercando di irradiare un po’ di calore a chi si accosta alla fiamma mentre fa
luccicare le fasce dei carabinieri pronti a manganellare chi non accetta a testa bassa l’ennesimo ricatto.
Eccolo ancora, con un giubbotto stavolta più pesante e meno sdrucito, con gli occhiali da sole pronti a
celare le occhiaie di giornate interminabili senza mollare un secondo. Lo sguardo deciso e il cellulare che
si trasforma in microfono per raccontare del picchetto e della lotta: “Oggi siamo qui in tanti, abbiamo
resistito alle cariche della polizia e andremo avanti perché non è che questi signori ci mettono paura,
continueremo, come e quando vogliamo perché nessuno potrà fermare la nostra determinazione”.
In quei giorni, e ancora oggi, nei blocchi davanti ai portoni di chi pensa solo ai soldi e sputa sulla vita
della gente si dice che il facchino paura non ne ha.
E Olol paura non ne ha, perché eri là anche tu, all’alba, davanti alla fabbrica da bloccare, stretto attorno a
chi ha deciso di lottare, per dare una mano, per urlare fino a perdere la voce e per organizzare il meglio
possibile la resistenza.
E non hai mai smesso di farlo, di esserci, di parlare e organizzare le lotte.
Dai tanti ragazzini arrivati nei vari posti dove si respirava autogestione, ai precari, migranti, sfruttati
incrociati nelle lotte e nelle vertenze hai dato tanto: parole, presenza e determinazione.
Oltre alla capacità di formulare la frase giusta al momento giusto, magari pure con la citazione che ci
calza bene.
Tra le tante cose che ho imparato da te e con te, una ci ha messo anni a divenire consapevolezza.
Cosa vuol dire rifiuto del lavoro? Conoscere la fatica delle levatacce e della schiena che fa dannare
certo, ma non ha senso se uno ne fugge da solo.
Rifiuto del lavoro vuol dire lottare in mille modi per strappare la dignità dalle unghie dei padroni e dai
manganelli della polizia.
Lottare insieme perché vogliamo vivere senza ricatti né sfruttamento e avere il tempo e le energie per
ridere e ballare. Perché senza musica non è la nostra rivoluzione.
Buon viaggio Olol, grazie di tutto.
– autoreverse – 30.09.2017