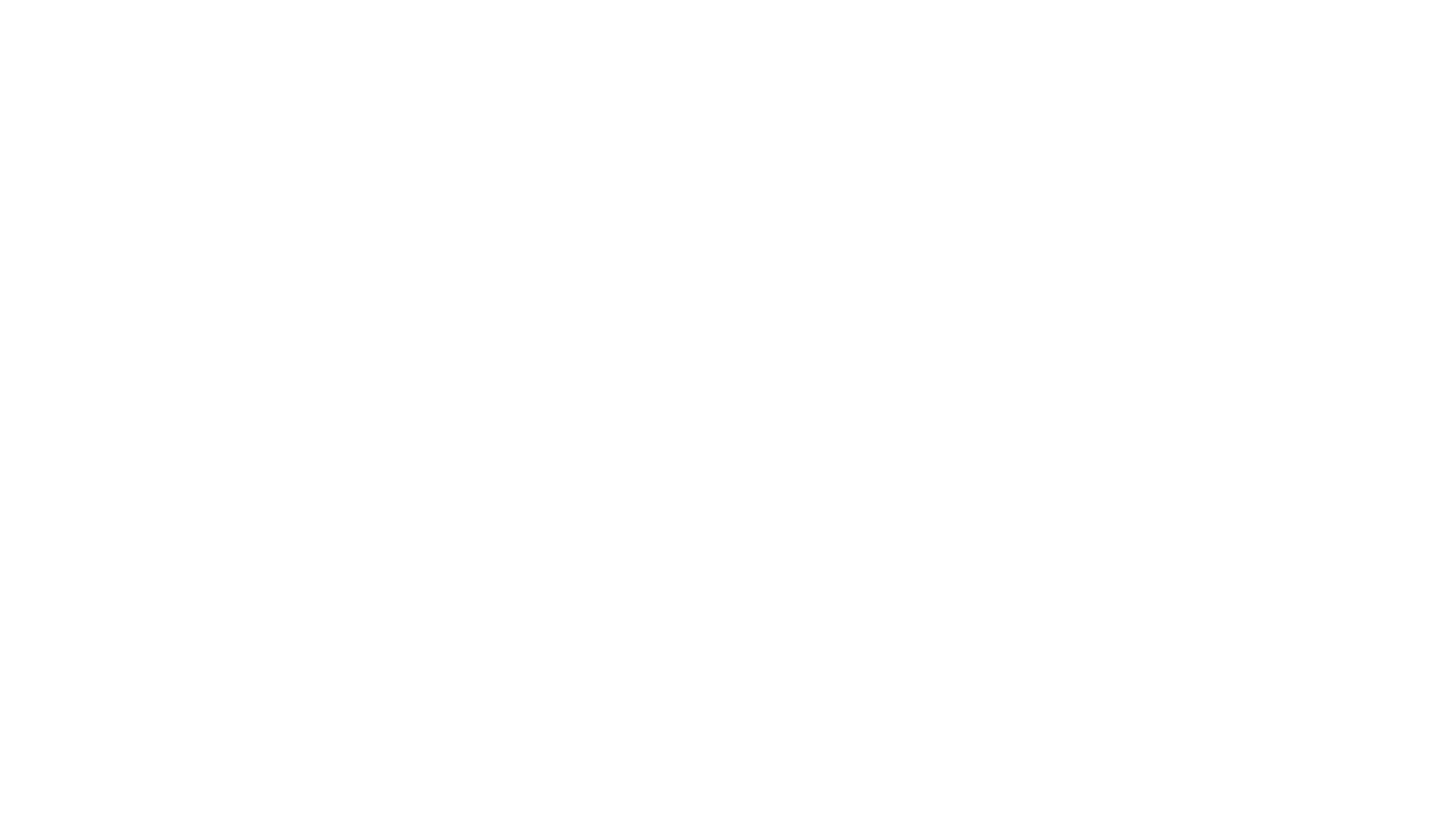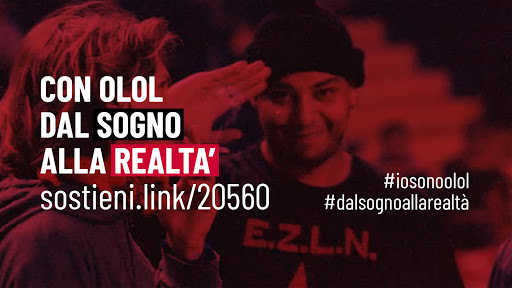“Fa parte dell’imbroglio: chiamano le cose con il nome opposto a ciò che veramente sono.“
Ken Loach Il primo dialogo incardina il film mettendoci davanti a uno schermo nero. Le argomentazioni riesumano l’immagine del sergente maggiore Hartman mentre in Full Metal Jaket indottrina una recluta in ordine alle opportunità che l’arruolamento può offrire a chi dimostra di saper lottare, di avere carattere, determinazione e spirito competitivo. Doti che il nuovo arruolato ha dimostrato di possedere. Senza che il dialogo si interrompa lo schermo si illumina sul massiccio capo organizzativo della filiale di Newcastle di una blasonata ditta di fast delivery. Ha i toni, i modi, la retorica, finanche qualcosa nella tenuta da lavoro sinistramente somigliante a una divisa militare, che integrano una declinazione del sergente Hartman. Di qualsiasi altro sergente. O caporale. Racconta a Riky, quarantenne rosso e tatuato, la balla del franchising che rende svincolati dal comando, dell’autodeterminazione del tempo di lavoro, dei conseguenti profitti. Non lavori per noi ma con noi, non timbri il cartellino, sei il capo di te stesso. Sei libero. Perché sei un guerriero. Ken Loch, classe 1936, con il suo ultimo lungometraggio Sorry we missed you conferma di non voler cambiare il segno del suo cinema. Dopo Me, Daniel Blake, sessantenne divenuto inabile al lavoro che incrocia i percorsi di inaccessibilità all’assistenza sociale con quelli di un’inattesa solidarietà è l’energico lavoratore Riky a condurci attraverso i territori del venir meno della lotta di classe, annientata dalla estinzione progressiva della grande fabbrica e dall’individualismo indotto dalla gig economy. Quell’economia digitale che sta disintegrando il concetto stesso del rapporto di forza quale indice del conflitto tra forza lavoro e centrali dello sfruttamento. Insegue un salto di qualità per poter acquistare una casa per se e la propria famiglia. Convince la moglie a vendere la piccola auto per acquistare un furgone. Dagli anziani non autosufficienti o i giovani handicappati presso i quali presta assistenza a cottimo lei andrà con i mezzi pubblici. Mentre lui scoprirà che 14 ore di lavoro non bastano, che anche l’inadempienza maggiormente giustificata viene pesantemente sanzionata. Che essere padre a queste condizioni diventa un secondo lavoro che non gode più del tempo necessario per capirsi e aiutarsi. E’ diventato schiavo della sua pistola. Ma non è on comizio, tantomeno un sermone, quello che ci (ri)propone Ken il Rosso. Anche se i suoi capelli sono diventati bianchi la sua determinazione a farci guardare al presente non ha nulla che attenga alla volontà di impartire lezioni. Nessuna presunzione, nessuna morale. Il fido cosceneggiatore Paul Laverty ha trascorso un anno affiancando lavoratori delle consegne e assistenti domiciliari. La scrittura che ne è seguita ha strutturato una confezione cinematografica asciutta, senza orpelli e senza enfasi. Che sfiora la docufiction mantenendo contestualmente una tensione drammatica che schiaccia lo spettatore sulla poltrona dal primo all’ultimo fotogramma. I giorni che separano la fascinazione di Riky per una nuova vita free lance dal precipitare in una voragine di delusione e depauperamento sono terribilmente pochi. Sufficienti però a mettere in crisi l’armonia familiare mentre sempre più chiare divengono le chiavi di sfruttamento che si sono impadronite della sua vita. Sufficienti soprattutto per noi per interrogarci ancora una volta sulle dinamiche che hanno portato a queste soglie di annientamento delle possibilità di rivendicare l’accesso ai diritti più elementari. Di azzeramento del potere contrattuale del lavoratore. Di difficoltà a praticare collettivamente terreni di solidarietà e di lotta. Sui meccanismi di induzione al consumo, l’effimera facilità di esercizio del quale ha creato una nuova merce immateriale: la velocità di accesso. Possiamo acquistare un oggetto certamente non indispensabile senza muoverci da casa, dove ci verrà recapitato in tempi brevissimi. Possiamo chiederci se davvero avevamo bisogno di tutto questo. Possiamo optare, alla fine del film, per un sentimento di tristezza, di rabbia o di indignazione. Possiamo però anche ricordarci che senza conflitto non c’è futuro.