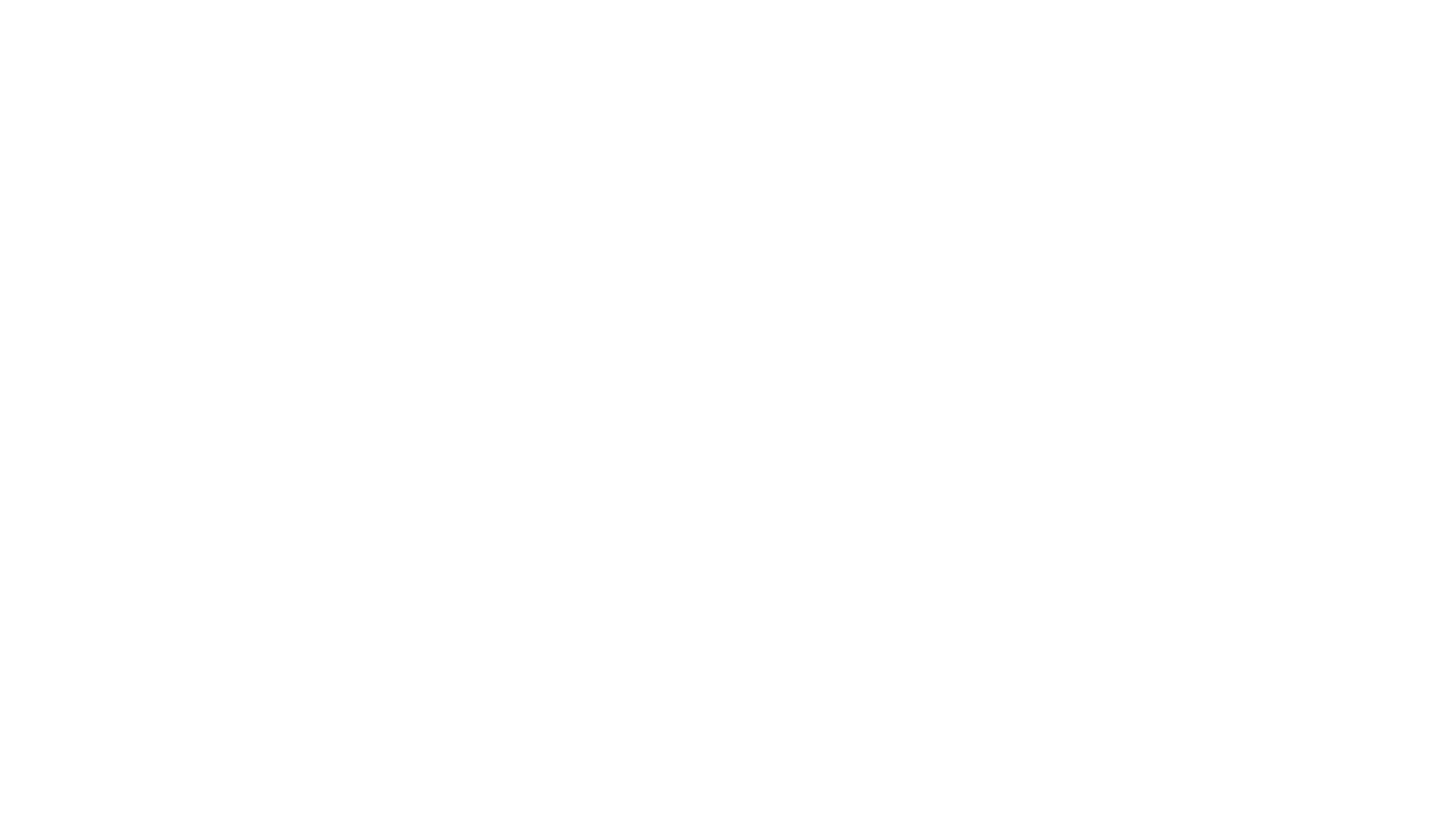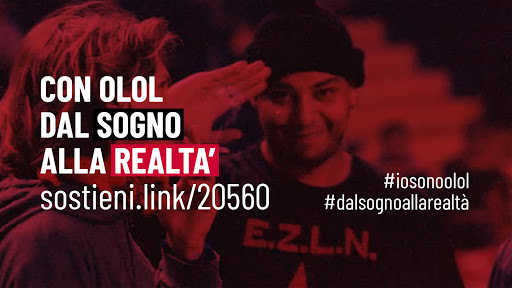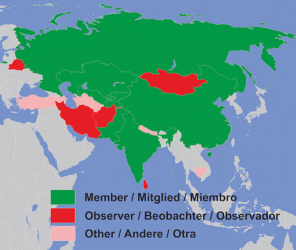Da un po’ di tempo a questa parte si sta discutendo della proposta avanzata dal M5S di introdurre per legge un salario minimo non inferiore ai 9 € lordi per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici. Al di là dello scopo strumentale del M5S volto a recuperare sul piano elettorale il consenso perso con le ultime elezioni europee, resta il fatto che ben al di sotto della soglia di 9 euro di retribuzione oraria esistono molte tipologie di contratti di lavoro sia di lavoro subordinato, che per le partite IVA, i parasubordinati e i soci di cooperative e quant’altro. In merito a questo dibattito i più apertamente critici contro la proposta dei grillini sono stati i sindacati confederali – salvo alcuni ripensamenti dell’ultima ora da parte della CGIL – i quali sono convinti che stabilire per legge un salario minimo rischi di assestare un colpo mortale al sistema della rappresentanza e dei contratti. I sindacati confederati sostengono che se ci sono tipologie lavorative scoperte dalla contrattazione si deve semmai intervenire su quelle e propongono di dare valore legale ai minimi retributivi dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente o comparativamente più rappresentativi.
Ma siamo sicuri che quanto paventato dai confederali succederebbe davvero? E poi: il sistema della contrattazione collettiva garantisce oggi un livello retributivo adeguato, oppure siamo in presenza sia di contratti collettivi di comodo – sottoscritti da OO.SS pirata – che di contratti collettivi firmati da CGIL CISL UIL ugualmente ridicoli e vergognosi con minimi salariali comunque sotto i 9€ orari? Lo scenario attuale fotografa livelli retributivi per significative fasce di lavoratori, frutto della contrattazione nazionale o della precarizzazione del lavoro, ben al di sotto di quanto stabilito dall’art. 36 della Costituzione. La discussione su salario minimo per legge o meno dovrebbe affrontare il nodo della garanzia per tutti di un salario di base che garantisca dignità e soglie superiori alla mera sopravvivenza. Va precisato a tale proposito che i 9 euro orari della proposta di legge equivalgono a un salario mensile netto al di sotto di 1200 euro. E in questa fascia di reddito troviamo lavoratori a tempo determinato o indeterminato sulla sogli della povertà o del tutto interni a tale soglia.
Scendendo più nel particolare degli attuali livelli retributivi di moltissimi comparti del lavoro troviamo una quantità enorme di CCNL con paghe orarie minime scandalose: i contratti sottoscritti dai confederali categoriali dei dipendenti Enti Lirici prevedono una paga oraria di euro 4,33 lordi per una retribuzione mensile lorda di 750 €; quello per i dipendenti della vigilanza privata (Servizi Fiduciari) – si tratta di personale che lavora nel campo della vigilanza privata e della guardiania in strutture pubbliche (Università, Case dello Studente, Istituti Bancari anche con compiti di responsabilità) e private – prevede una paga oraria lorda di 4,60 euro per un totale mensile lordo di meno di 800 euro ; il contratto per il personale ATA si avvicina alla soglia dei 9 euro con gli 8,29 euro orari previsti. Rimangono all’interno di questa forbice una infinità di altri contratti che coinvolgono milioni di lavoratori dell’abbigliamento, delle agenzie di viaggio, dell’agricoltura (tra 5,17 € e i 6,94 all’ora per gli operai qualificati), degli alberghi, del calzaturiero, delle case di cura, del commercio, del florovivaismo, delle cooperative sociali, dell’edilizia artigiana, del facchinaggio, degli impianti sportivi, degli istituti socio assistenziali, della nettezza urbana, dei panifici, del portierato, dei pubblici esercizi, delle pulizie multiservizi, delle scuole private, degli stabilimenti balneari, dei teatri stabili, del terziario commercio, delle tintorie industriali, del turismo e della zootecnia. Tutti questi contratti hanno minimi contrattuali mediamente intorno ai 7,5 € con un salario mensile netto spesso al di sotto dei 1000 euro.
Il salario storicamente misura i rapporti di forza e, quindi, laddove vi sono stati cicli di lotta importanti a partire dagli anni 70 con protagonista una determinata composizione di classe – pensiamo solo ai metalmeccanici dove il salario di ingresso è di 7,63 € per diventare dopo 4 mesi automaticamente 8,42, con la possibilità di arrivare a 9,34 con un corso di formazione – i salari si sono assestati su un livello mediamente più alto rispetto alle retribuzioni orarie di una miriade di realtà lavorative che non sono mai riuscite, salvo qualche eccezione di cui parleremo più avanti, ad esprimere alti livelli di conflittualità. In ogni caso, anche per tipologie di lavoratori come i metalmeccanici sopra citati, il sistema della contribuzione e della tassazione porta ad un reddito netto mensile che non va oltre i 1200 € netti. Ciò che fa la differenza poi in questi comparti è la specializzazione – con il passaggio a livelli superiori – sono gli scatti di anzianità e i premi di risultato.
In settori industriali importanti come quello metalmeccanico, chimico, tessile e in alcuni altri settori della manifattura, nel corso di questi ultimi due decenni il potere contrattuale si è tuttavia di molto ridimensionato a causa dei processi sempre più spinti di delocalizzazione verso paesi con un costo del lavoro pari circa ad un quinto di quello esistente nell’Europa occidentale e per la contestuale entrate a pieno titolo di forme di lavoro sempre più precarizzate che convivono con quelle dei cosiddetti “garantiti”, con salari nettamente inferiori. L’inserimento di queste forme di lavoro precario ha prodotto una stratificazione all’interno della forza lavoro occupata e contribuito ad indebolire la forza contrattuale dei lavoratori impiegati e a rendere difficoltosi i percorsi di lotta. In situazione di fabbrica, infatti, vediamo come lavoratori inseriti nello stesso ciclo produttivo con contratti e datori di lavoro diversi perdono spesso la consapevolezza di essere tutti lavoratori con le medesime aspirazioni in termini di salario e diritti. E’ questo tipo di precarietà lavorativa ad aver indebolito complessivamente il potere contrattuale dei lavoratori, insieme ovviamente alle dinamiche della globalizzazione neoliberista. Tutto questo non ha nulla a che vedere con i rischi paventati dai sindacati confederali a proposito della proposta di salario minimo. Ci fosse per legge il varo di questa soglia minima di tutela salariale, nulla impedirebbe alle organizzazioni sindacali di mantenere aperta la contrattazione nazionale e quella di secondo livello, visto che comunque 9 euro all’ora non fanno diventare nessuno ricco.
Per meglio argomentare come il salario sia comunque la misura dei rapporti di forza è il caso di richiamare il ciclo di lotta che si è prodotto negli ultimi 10 anni nel settore del trasporto merci e della logistica, all’interno del quale una vera e propria rivolta di una forza lavoro per lo più composta di migranti è andata ad impattare pesantemente con le varie multinazionali che gestiscono la logistica in Italia, (da TNT/Fedex, BRT, GLS, SDA, DHL ecc). Questo ciclo di lotta ha prodotto oltre che un processo di regolarizzazione dei rapporti di lavoro e di conquista di diritti sul piano contrattuale e normativo, anche significativi aumenti salariali, portando la busta paga da meno di 7 euro all’ora lordi, agli attuali 11 euro lordi per chi ha una anzianità di 10 anni, imponendo con la lotta l’introduzione di vari istituti, dal ticket restaurant, ai passaggi automatici di livello, al premio di risultato.
L’introduzione di un salario minimo, anche se solo a livello nazionale, ha di per sé sicuramente un forte significato materiale e politico andando a definire una soglia di reddito minimo da lavoro che risponderebbe, quanto meno, al dettato costituzionale. Dichiararsi contrari al salario minimo non trova nessuna ragione da parte di chi difende i diritti dei lavoratori.
La questione che poniamo noi semmai è che, al di là di quello che deciderà questo governo – e probabilmente non avremo alcuna legge sul salario minimo – la rivendicazione di un salario minimo va posta come obiettivo conflittuale nei posti di lavoro e rilanciata sul versante europeo affrontando conflittualmente il ruolo neoliberista, a totale beneficio delle imprese multinazionali, giocato dalla UE. L’attuale Europa a 28 Stati è garante dell’imposizione di una riorganizzazione del comando capitalistico dove la delocalizzazione delle imprese e del lavoro interna all’Unione garantisce salari differenziati da Stato a Stato e una mobilità della forza-lavoro migrante interna ed extraeuropea funzionale a questo sistema di gabbie salariali. Un esempio evidente è quello di Amazon che ha costruito 4 impianti in Polonia da cui parte la distribuzione dei pacchi per la Germania e dove vi lavorano circa 4000 operai con un salario di 400 € al mese, mentre i lavoratori tedeschi della multinazionale percepiscono un salario parametrato ai livelli medi della Germania. Analoghi esempi si potrebbero fare per questa condizione salariale differenziata in Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Slovacchia, ma anche in Croazia e Serbia, uno ormai dentro l’Unione e l’altro in attesa di entrarci, dove sono arrivati a pioggia gli investimenti ma anche le agenzie di reclutamento di manodopera, qualificata e non, a basso costo.
E’ quindi evidente che la questione del salario minimo deve essere posta in termini di prospettiva di lotta sul piano europeo, rivendicando un salario minimo uguale per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Si tratta ovviamente di un percorso lungo e difficile, ma dal quale non si può prescindere. In questo senso è necessario sviluppare tutti i contatti a livello europeo tra le varie realtà del sindacalismo conflittuale per costruire una prospettiva di lotta che riesca su questo terreno ad incidere realmente eliminando queste macroscopiche differenze salariali.
A fianco di questo percorso di lotta risulta fondamentale per ottenere l’aumento del salario e del reddito affrontare la questione fiscale. Nel nostro Paese in particolare il rapporto oggi tra salario e reddito ha direttamente a che vedere con il fisco: paradossalmente per quella parte di lavoratori che grazie alle lotte hanno raggiunto livelli retributivi dignitosi – un reddito lordo annuale che supera i 24.600, cioè circa 1750 € lordi al mese che in termini netti arrivano a circa 1350 € netti al mese per 14 mensilità – il superamento della soglia di 24600 € significa perdere progressivamente il “Bonus Renzi” cioè 960 € – che equivale a lavorare tre settimane gratis – ma anche vedersi ridurre le detrazioni fiscali e gli assegni familiari e contestualmente aumentare l’ISEE e quindi trovarsi con rette per asili o mense o tasse universitarie ulteriormente appesantite.
Insomma, al di là delle sparate sulla salviniana Flat Tax, di cui si sa solo che al momento produce una riduzione delle tasse ai liberi professionisti con un reddito familiare fino a 65000 euro, si tratta di affrontare con percorsi di lotta anche la relazione tra contribuzione e fisco per produrre un aumento effettivo del reddito. Lo si deve fare, però, salvaguardando e, anzi, rinforzando l’intero sistema di welfare, dal sistema sanitario a quello assistenziale, dal sistema pensionistico a quello dell’istruzione, recuperando in altro modo quella parte di contribuzione dello stato sociale che garantisce l’iniquo e quasi esclusivo prelievo fiscale sui redditi da lavoro. Quanto ottenuto su questo terreno in Francia dal movimento dei gilets jaunes è un esempio di come un movimento composito della società civile, fatto di lavoratori, studenti, cittadini, possa imporre delle politiche a governi votati al credo neoliberista, sovranisti o meno.