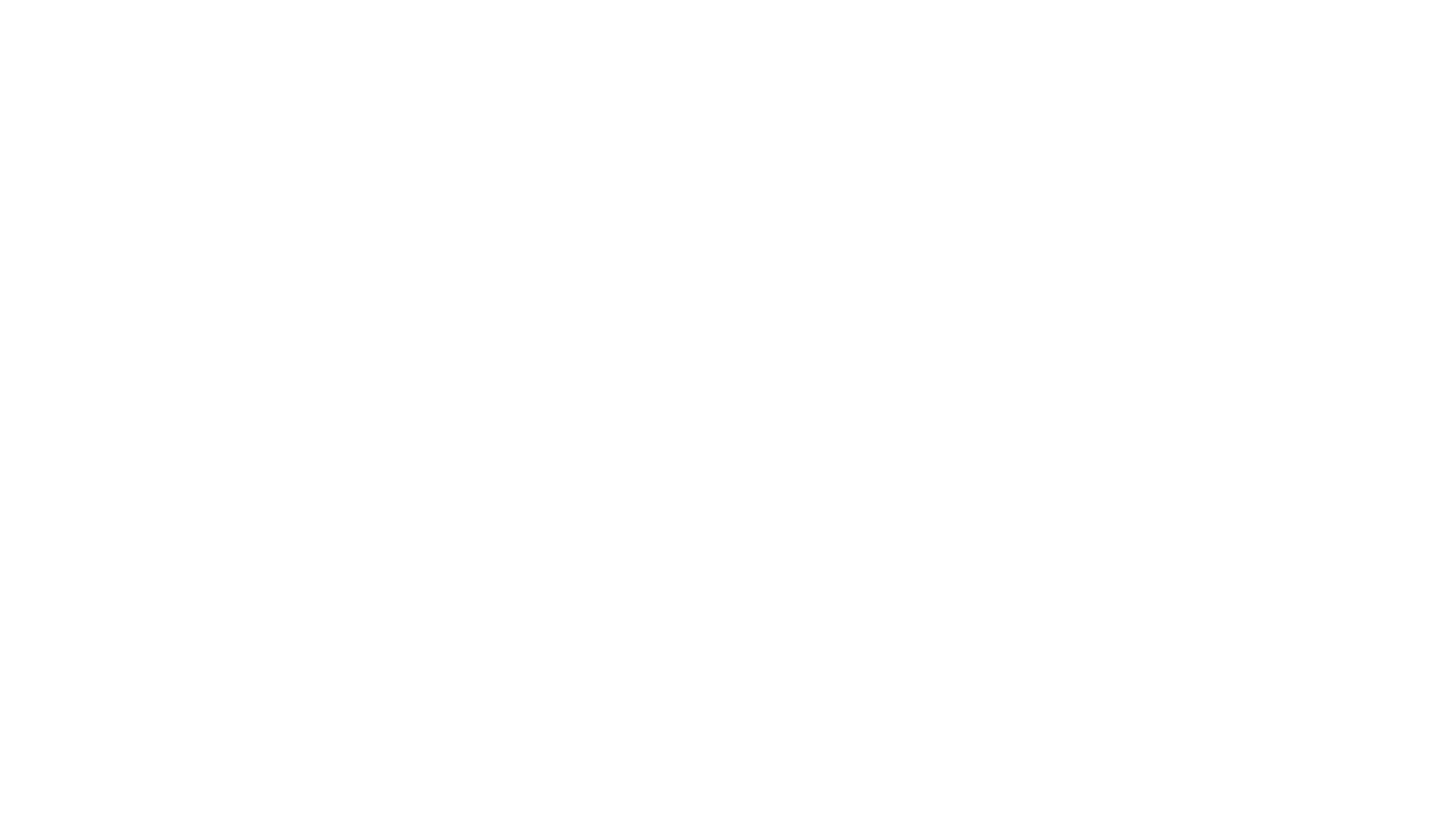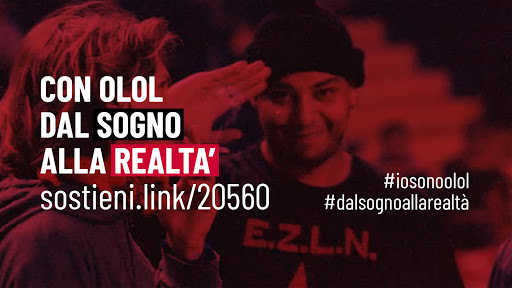Nelle ultime settimane c’è stata una ripresa del dibattito attorno al tema delle pensioni, a partire dall’imminente conclusione del sistema sperimentale di pensionamento anticipato, ovvero il cosiddetto “quota 100”, che prevedeva per una minoranza la possibilità di andare in pensione a 62 anni con una contribuzione minima pari a 38 anni. Senza una riforma, la Legge Fornero, che è bene ricordare non è mai stata cancellata e per molti ha continuato ad essere l’unica via per accedere alla pensione, sarà da ora in poi l’unica prospettiva pensionistica.
Quando, nel 2011, è stata adottata la riforma Fornero del sistema previdenziale, gli aspetti che hanno più inquietato e scandalizzato sono stati l’innalzamento dell’età pensionabile e il passaggio al sistema contributivo. Proprio a causa dello slittamento in avanti del requisito d’età, migliaia di persone che avevano stretto accordi con i propri datori di lavoro, si sono ritrovate improvvisamente senza stipendio, senza lavoro e, il più delle volte, senza ammortizzatori sociali. Le sorprese non finirono qui: una volta giunti al tanto bramato traguardo i soldi messi a disposizione non sarebbero più stati gli stessi perché la semplice e apparentemente innocua sostituzione della parola “retributivo” con la parola “contributivo” modificò il sistema di calcolo abbassando vertiginosamente l’importo delle pensioni future e in modo esponenziale: più tardi hai iniziato a lavorare, più bassa sarà la tua pensione.
Sfuggì in quel momento di shock emozionale un ulteriore gravissimo aspetto introdotto dalla riforma. I lavoratori e lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, hanno il diritto ad andare in pensione solo se, oltre ad aver compiuto 67 anni e aver raggiunto i 20 di contributi, il loro assegno pensionistico non è inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (nel 2021 pari o superiore a 690 euro mensili), altrimenti dovranno aspettare di avere 71 anni.
La portata drammatica di questo meccanismo sarà visibile solo tra alcuni anni, quando chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 vorrà andare in pensione e scoprirà che non lo potrà fare. Il passaggio al puro sistema contributivo per chi ha iniziato a lavorare successivamente al 31 dicembre 1995, non prevedendo tra l’altro la possibilità di essere integrato al trattamento minimo (il famoso “milione”), determinerà infatti pensioni basse, bassissime per tutt@ negando l’accesso alla pensione fino al compimento dei 71 anni, quando basteranno soltanto il requisito anagrafico e quello contributivo di almeno 5 anni.
Tuttavia, già oggi possiamo toccare con mano i primi effetti di queste misure su colf e assistenti familiari. Si tratta perlopiù di donne migranti, arrivate in Italia negli anni Novanta, non giovanissime, che hanno potuto regolarizzare la propria posizione lavorativa grazie alle due grandi sanatorie del 1998 e del 2001 e che stanno raggiungendo proprio in questi anni i requisiti di età e di periodo contributivo. Queste lavoratrici arrivano nei nostri uffici con lo sguardo di chi spera di poter abbandonare un lavoro usurante e altamente faticoso, che le ha logorate nel corso degli anni e che faticano a reggere ancora e, soprattutto, di poter trovare finalmente un po’ di riposo e tempo per sé, dopo una vita amara dedicata totalmente alla cura di altre persone, giorno e notte, senza soluzione di continuità. E’ in quel momento, quando si rivolgono ai nostri sportelli che arriva, però, la dolorosa sorpresa. Non solo scoprono di dover lavorare ancora per altri 4 anni, perché non superano la soglia richiesta che prevede di avere maturato una pensione di almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, ma realizzano anche che la loro “ricompensa pensionistica” si aggirerà tra i 200 e i 350 euro, una cifra evidentemente misera, insufficiente per vivere.
La causa principale di questa grave ingiustizia è legata al minor valore riconosciuto ai contributi derivanti dal lavoro domestico, che riflette la strutturale svalutazione sociale del lavoro di riproduzione pagato e non pagato. Infatti, il calcolo della pensione con il sistema contributivo tiene conto esclusivamente dei contributi che il lavoratore versa e accumula negli anni, come se vi fosse una sorta di conto corrente virtuale. I salari molto bassi e il versamento di contributi esigui, il tipo di lavoro spesso a tempo parziale e con carriere discontinue, la frequente irregolarità del rapporto lavorativo, la ridotta percentuale contributiva rispetto agli altri lavoratori dipendenti, concorrono a formare un “misero libretto contributivo virtuale” che determinerà una povera pensione. Tuttavia, non c’è da illudersi, anche nel caso di lavoro a tempo pieno e con contributi versati per lunghi periodi, il risultato sarà sempre deludente: se, per esempio, una colf lavorasse continuativamente 40 ore a settimana, dopo 40 anni raggiungerebbe una pensione di circa 450 euro al mese.
Dopo anni di duro lavoro in Italia, le lavoratrici impiegate nel settore dei servizi domestici e di cura, finiscono per cadere in povertà e sono costrette a rivolgersi agli schemi di integrazione del reddito previsti in questi casi, quali l’assegno sociale e la pensione di cittadinanza. Anche se di nuovo il sistema di welfare state italiano riserva loro ulteriori spiacevoli sorprese.
Trovarsi a 71 anni con una pensione di 200-300 euro costringe le neo-pensionate a cercare sostegno presso i propri familiari per affrontare le spese ordinarie (affitto, bollette, alimentari, ecc.). Le colf e le badanti in pensione si ritrovano, quindi, a dover optare per la convivenza con i figli ma, così facendo, perdono la possibilità di accedere alla pensione di cittadinanza perché superano il requisito economico, in quanto il loro reddito si somma a quello dei familiari coresidenti nella determinazione dell’ISEE.
L’altro schema di integrazione del reddito al quale potrebbero accedere le lavoratrici domestiche in pensione è l’assegno sociale. Tuttavia, anche in questo caso l’accesso a tale misura è irto di ostacoli. Le pensionate di cittadinanza straniera devono produrre una documentazione tradotta e legalizzata che attesti la presenza o meno di proprietà immobiliari nel Paese di origine e/o di pensioni estere. Mentre l’eventuale pensione estera non è incompatibile ma concorre al ricalcolo dell’assegno sociale, la presenza di una proprietà diversa a quella di residenza è invece ostativa. Se, quindi, una lavoratrice ha (giustamente) tenuto il suo piccolo appartamento nel Paese d’origine non potrà aver diritto all’assegno sociale.
Le problematiche che incontrano le lavoratrici domestiche migranti nell’accesso alla pensione sono emblematico sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto, questo caso fa emerge in tutta la sua portata le carenze del sistema di welfare state italiano che ha storicamente scaricato la cura delle persone anziane e non autosufficienti sulle famiglie e quindi sul lavoro gratuito delle donne. Inoltre, ormai da alcuni decenni assistiamo a un processo di mercificazione della cura, che consiste nell’impiego di un crescente numero di lavoratrici migranti come assistenti familiari. La domanda di cura viene quindi soddisfatta da centinaia di migliaia di migranti, che in Italia si inseriscono in un mercato dell’assistenza fatto di competizione al ribasso, salari miseri, mansioni dequalificate e condizioni di lavoro totalizzanti, spesso con rapporti contrattuali solo in parte regolari. A questa categoria di lavoratrici, che rappresenta un pilastro indiscusso dello regime di cura italiano, è però riservato un destino pensionistico beffardo, fatto di vulnerabilità e povertà. Questo caso ci mostra, inoltre, quello che succederà tra qualche anno se non verrà riformato radicalmente il sistema pensionistico, garantendo un reddito dignitoso a tutti gli individui a prescindere dalla loro storia lavorativa e dal luogo in cui sono nati. Allo stesso modo l’intero sistema di welfare state che attualmente è costruito attorno a una logica emergenziale ed è frammentato in una miriade di bonus volti a coprire di volta in volta le situazioni di bisogno, dovrebbe essere riconsiderato profondamente. Come ci ha mostrato la pandemia, tutt@ possiamo diventare vulnerabili ed è proprio questa condizione comune che deve far ripensare l’azione pubblica e privata verso una ristrutturazione del welfare che metta in campo azioni complessive e non interventi mirati a rimediare alle singole falle del sistema.