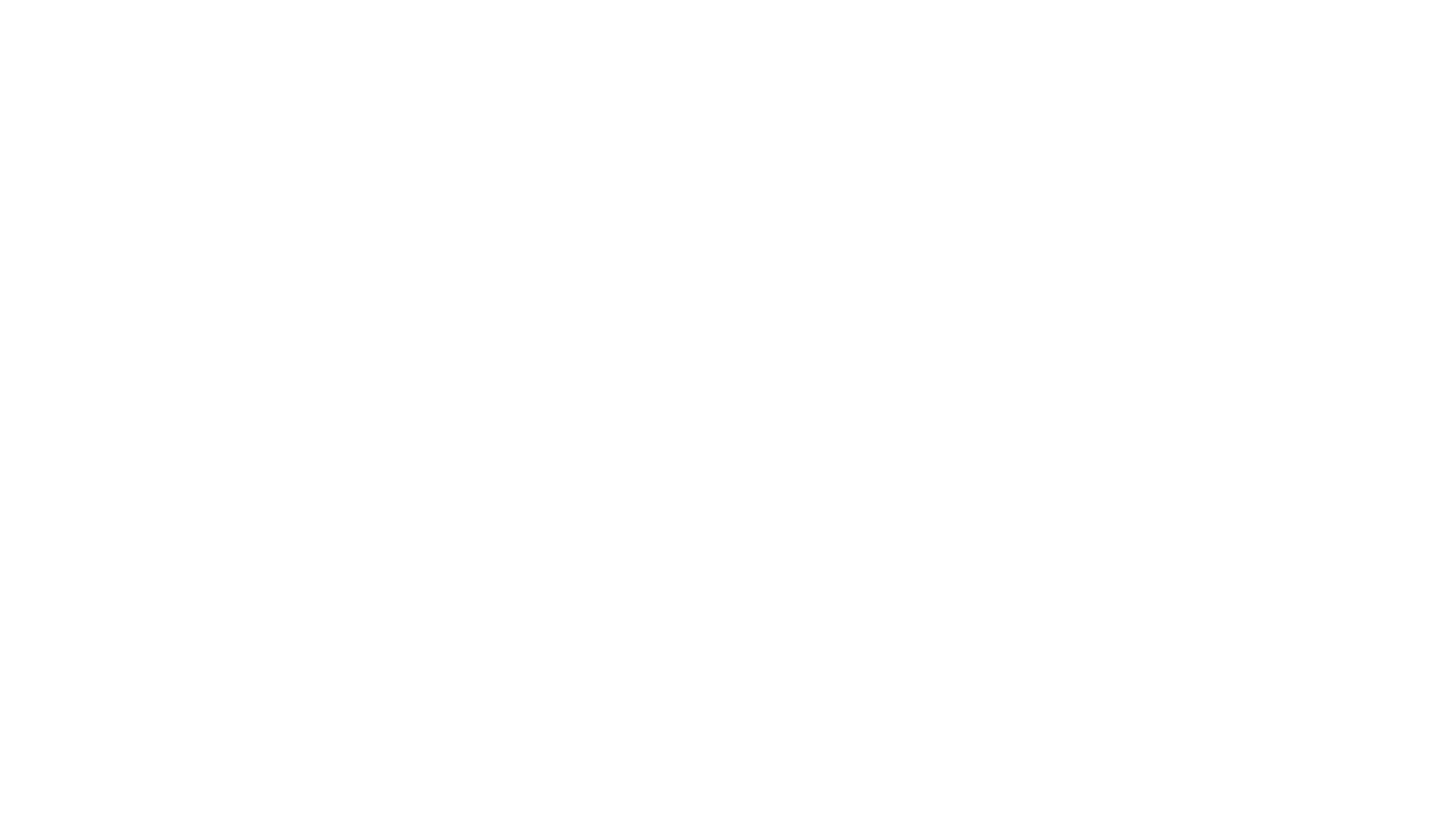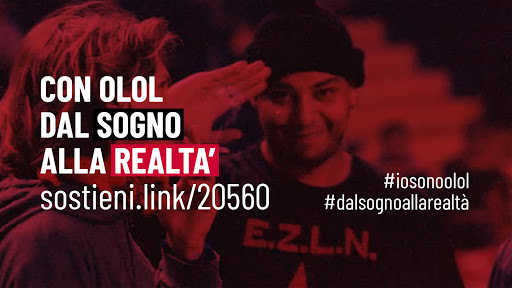Alcune considerazioni sul senso politico del corteo sindacale del 20 giugno
Riportiamo la riflessione pubblicata sul blog dell’Assemblea territoriale per il Reddito di Rimini.
L’Emilia-Romagna viene spesso descritta, da chi la amministra, come uno dei territori più avanzati e competitivi d’Europa, una culla del buon governo e dei diritti, sede di un’economia che corre veloce ma senza lasciare indietro nessuno.
Eppure sabato 20 giugno a Bologna è successo qualcosa che potrebbe incrinare questa narrazione. Un ampio corteo di lavoratrici e lavoratori provenienti dall’intera Regione ha attraversato le vie del centro, sostenendo che le loro condizioni di vita e di lavoro non sono così idilliache come si vorrebbe far credere e rivendicando diritti, soldi e salute.
Si tratta di quella galassia di figure lavorative la cui situazione di precarietà e sfruttamento è emersa con ancor più chiarezza durante l’emergenza Covid: lavoratori della logistica, riders, lavoratori dello spettacolo, figure del terzo settore, dei servizi educativi, della sanità, operatori dei servizi, dalle mense alle pulizie, ecc.
Questa iniziativa è nata dalla convergenza di diverse organizzazioni del sindacalismo di base (Adl Cobas,Si Cobas, Cobas, Sgb) ma è stata in grado di esprimere più che una mera sommatoria di sigle. Quella piazza ha avuto in effetti la capacità di essere, almeno in parte, espressione reale delle tensioni e dei conflitti che attraversano il tessuto sociale regionale. Solo alcuni anni fa un corteo così eterogeneo e denso di storie individuali e collettive sarebbe stato semplicemente impensabile.
Tutto ciò evidentemente non nasce dal nulla ma è il frutto di processi molecolari, spesso invisibili ai più, che si sono dispiegati nel corso dell’ultimo decennio. Così, per esempio, se i facchini non si fossero resi protagonisti degli aspri conflitti che hanno caratterizzato la logistica emiliana, il corteo del 20 non sarebbe stato possibile, almeno non in quella forma; se gli educatori/trici e tutto il mondo del terzo settore non avesse davvero iniziato a mobilitarsi per mettere in discussione il sistema degli appalti a ribasso nei servizi pubblici il senso di quella giornata non sarebbe stato lo stesso.
Perché dunque tanta distanza tra il racconto proposto dalle istituzioni e le condizioni materiali emerse dalla manifestazione del 20 giugno?
Perché nei discorsi ufficiali e nelle campagne elettorali questo pezzo di società, sul cui lavoro si reggono interi settori di economia, non viene mai preso in considerazione e le sue problematiche semplicemente sembrano non esistere?
Di certo, ammettere l’esistenza di queste lavoratrici e lavoratori, legittimarne le rivendicazioni, significherebbe incrinare la visione di un territorio inclusivo, dinamico, laborioso, il cui sviluppo si regge su un sistema produttivo di qualità, nell’ambito del quale aziende e lavoratori sono uniti nel perseguimento di un comune orizzonte di sviluppo e benessere; sostenere che anche nel tanto decantato modello emiliano ci sono vincitori e perdenti contribuirebbe, perciò, a deteriorare l’immaginario su cui le élites politiche locali hanno costruito e consolidato il proprio consenso.
Tale consenso si regge infatti su un modello di governance neocorporativa: un sistema di regolazione sociale in cui alle grandi organizzazioni sindacali e imprenditoriali viene attribuito ex lege il monopolio della rappresentanza delle rispettive categorie, i cui interessi vengono formalmente ricomposti, attraverso solidi meccanismi di concertazione, all’interno di un quadro unitario che dovrebbe garantire benefici a tutte le parti della società.
L’espressione più genuina di tale impostazione è il Patto per il Lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna e sottoscritto nel 2015 da sindacati confederali, organizzazioni di categoria e dei datori di lavoro, enti locali, istituzioni universitarie con lo scopo dichiarato di favorire la crescita, la competitività e l’equità del sistema territoriale. Questo modello è stato di recente rilanciato con il progetto del Patto per il Clima che dovrebbe incorporare a sua volta alcune istanze di carattere ecologico.Tutto ciò che si muove al di fuori di questo ombrello concertativo, non può perciò essere legittimato in quanto elemento di disturbo della presunta armonia sociale che l’intero dispositivo vorrebbe restituire. Il problema è che questa armonia esiste solo sulla carta e si regge su una doppia illusione: da un lato che nell’ambito dell’attuale sistema di mercato esistano i margini per garantire a tutti un adeguato livello di benessere, salvaguardando allo stesso tempo i profitti; dall’altro, che il sistema concertativo sia davvero in grado di rappresentare e comporre l’intero spettro degli interessi sociali.
Decenni di liberismo hanno mostrato che in un modello produttivista e ipercompetitivo ci sono vincitori e sconfitti. Niente fa pensare che ciò possa essere diverso nell’ambito di un’economia di mercato più green se i meccanismi di fondo e i rapporti di forza nella società restano inalterati. In sostanza, nel momento in cui un intero territorio viene trasformato in una piattaforma produttiva fortemente orientata all’export (ed è il percorso su cui è instradata da anni la nostra Regione), l’intero sistema deve essere estremamente competitivo e avere la capacità di attrarre e accaparrarsi quote crescenti del valore che circola sulle reti globali.
Questo inevitabilmente si traduce in pressioni al ribasso sul costo dei fattori produttivi, a partire ovviamente da quello della forza-lavoro. Persino nei contesti più innovativi si assiste a dinamiche polarizzanti, in cui allo sviluppo di professioni qualificate fa da contrappunto la diffusione di tanto e tanto lavoro estremamente flessibile e poco remunerato, a volte addirittura povero, soprattutto nelle fasi dei cicli produttivi e riproduttivi a più alta intensità di manodopera (in primis i servizi all’impresa e alla persona). Di qui tutto un sistema di esternalizzazioni, appalti e subappalti, sia pubblici che privati, fondato sulla necessità di ridurre i costi ed aumentare la flessibilità nel reclutamento e nell’impiego dei lavoratori. Senza questa ampia quota di lavoro a buon mercato su cui scaricare i costi occulti (le esternalità direbbero gli economisti) della competitività, quegli stessi sistemi non riuscirebbero a fare fino in fondo ciò che è nella loro natura, a perseguire indiscriminatamente l’obiettivo per cui sono stati creati: la massimizzazione dei profitti.
Questo significa che le condizioni di lavoro denunciate dalla piazza del 20 giugno non rappresentano un incidente di percorso, ma un elemento strutturale e vitale di un sistema economico il cui faro non è il benessere delle persone, ma la produzione di merci. Non a caso la composizione di quella piazza è lo spaccato di queste aree sempre più estese del mercato del lavoro.
Fintantoché la nostra Regione verrà concepita solo e semplicemente, per usare un’espressione usata in qualche occasione dal suo attuale Presidente, come un sistema che esporta merci ed importa turisti, sarà estremamente complicato uscire da questo cortocircuito. Quando si parla di eccellenze produttive, di internazionalizzazione delle imprese, di distretti manifatturieri o agroalimentari emiliani come esempi di sviluppo virtuoso ci si dovrebbe perciò interrogare sulle zone d’ombra che inevitabilmente tutto ciò produce.
Tutti questi elementi, per esempio, sarebbero sostenibili, entro i confini di un’economia prettamente orientata al profitto, senza una catena logistica efficiente in grado di ancorare saldamente quei comparti ai mercati internazionali, di garantire la circolazione costante e fluida di input produttivi e merci?
E queste stesse catene logistiche sarebbero immaginabili, nell’ambito di questo sistema, senza lo sfruttamento del lavoro a buon mercato di coloro, spesso migranti, che vi trovano impiego? Tutto ciò avrebbe senso senza quei magazzini e quelle reti di trasporto la cui attività si regge sullo spietato sistema di reclutamento guidato dalle cooperative dentro ad un’intricata rete di fornitura e appalti?
Lo stesso identico ragionamento può essere esteso ad altri comparti dell’economia a partire dal turismo che opera secondo le stesse logiche in un quadro in cui non è la merce che deve essere trasportata nei luoghi di consumo, ma i consumatori attratti verso il territorio-merce.
Ma lo spirito della competizione a ribasso pervade anche settori non direttamente esposti ai venti del mercato globale, imponendo una impostazione aziendalistica ed efficentista tutta giocata sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, come avviene nel sistema di appalti nei servizi pubblici. Il welfare mercificato e privatizzato avrebbe ragione di esistere senza l’esercito di lavoratori e, soprattutto, lavoratrici a basso costo (educatrici, OSS, infermieri, ecc..) che ne regge le sorti? Gli ipertrofici apparati del terzo settore che vivono di fondi pubblici riuscirebbero a ritagliarsi margini di guadagno utili a garantire la propria sopravvivenza se i loro dipendenti fossero adeguatamente retribuiti e avessero diritti e condizioni contrattuali degni di un paese civile? La partita dunque si gioca in modo sempre più evidente sul piano politico, sulla capacità cioè di proporre alternative complessive alla centralità del mercato. Quando gli operatori sociali rivendicano la fine del sistema degli appalti e l’internalizzazione dei servizi alla persona da parte degli enti pubblici, mostrano di aver colto con lucidità questo aspetto: non è possibile chiedere fino in fondo reddito e diritti senza mettere in discussione un sistema che si regge sulla sistematica negazione di queste stesse aspirazioni.
Tutto ciò ha ovvie ripercussioni sull’altro corno della questione, quello della rappresentanza degli interessi. All’interno dell’attuale quadro politico ed economico i margini di mediazione per recuperare e cooptare nell’ambito del sistema concertativo i nuovi segmenti di classe lavoratrice sono estremamente esigui. E questo perché, come già sostenuto, la loro condizione di sfruttamento è elemento costitutivo dell’attuale modello di sviluppo ed è difficile immaginare correttivi che non vadano a modificare i rapporti di potere che ne stanno alla base. Visto da questa prospettiva l’attuale infrastruttura della rappresentanza imposta dall’alto non può che essere fittizia, puramente formale ed incapace di interpretarne in modo adeguato bisogni, interessi e aspirazioni, proprio perché piegata alla logica che ne limita il potenziale sviluppo e soddisfacimento. Di qui una dinamica centrifuga che porta crescenti settori di lavoratrici e lavoratori fuori dall’orbita del sindacalismo confederale che, evidentemente, non ha gli strumenti per organizzarli e fornire risposte soddisfacenti. Porsi il problema di farlo significherebbe creare delle fratture nel tessuto economico e produttivo regionale, obiettivo evidentemente in contraddizione con la partecipazione attiva ad un sistema di governance che si pone esplicitamente l’obiettivo di preservarne gli equilibri.
C’è un’ultima variabile che non va sottovalutata: lo scenario di drammatica crisi che l’emergenza sanitaria ha aperto. Il fattore crisi sta già contribuendo a peggiorare le condizioni di vita e ad inasprire le pressioni su ampi settori di forza-lavoro nel tentativo di salvaguardare i profitti nonostante la contrazione del mercato (o utilizzando quest’ultima come scusa). Dunque le tensioni aumenteranno e con ancora più chiarezza si andrà delineando nel prossimo periodo la necessità di un radicale cambio di prospettiva.
La piazza del 20 non è stata ovviamente risolutiva e non bisogna farsi prendere la mano da ingiustificati entusiasmi. Per evitare che la dinamica centrifuga che può mettere in crisi il sistema di sfruttamento diventi dispersiva occorre immaginarsi nuovi centri di gravità: alleanze tra settori diversi di mondo del lavoro, una nuova visione dei rapporti sociali ed ecologici, una contro-narrazione efficace e pervasiva, nuovi strumenti organizzativi e operativi, a partire da spazi comuni di iniziativa sindacale.
Ciò che quella piazza dimostra, però, è che i margini per poterlo fare ci sono tutti.