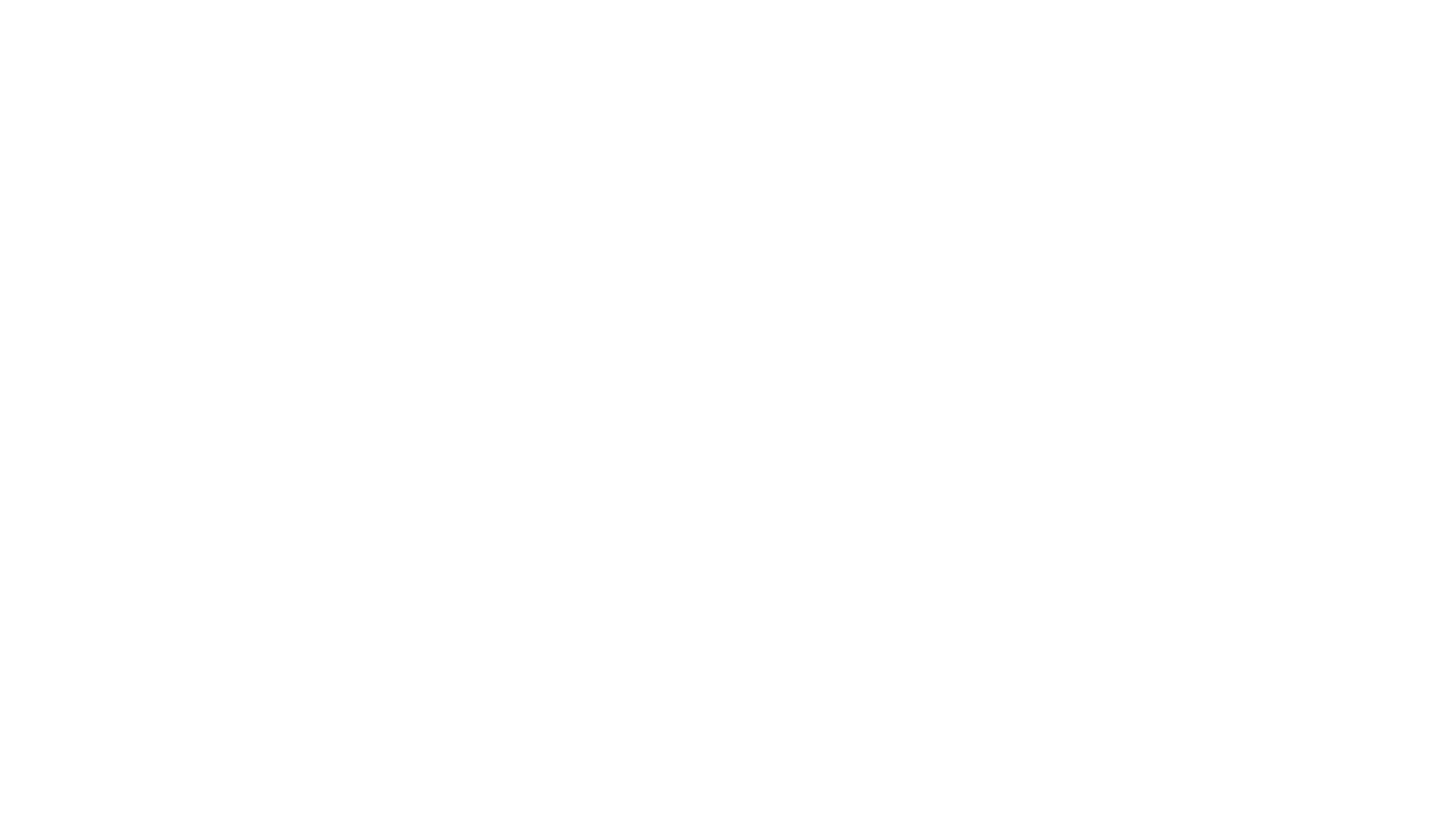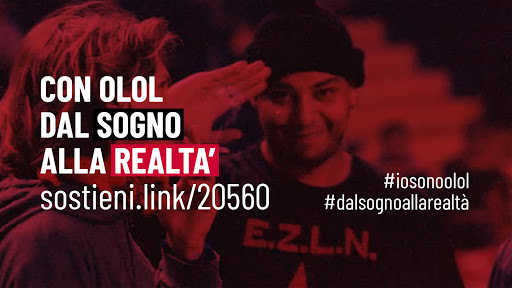La propensione del capitalismo a ricercare il massimo profitto sul piano mondiale non è caratteristica esclusiva dell’era della cosiddetta “globalizzazione”. La necessità di produrre ricchezza per pochi a scapito di molti avviene sia nelle forme consentite dalle leggi vigenti sia nelle azioni di rapina di risorse naturali e nella riduzione in schiavitù di interi popoli. Queste caratteristiche del capitalismo hanno attraversato tutte le fasi del suo sviluppo, durante le quali sono stati messi in campo tutti gli strumenti leciti e illeciti per sfamare una belva famelica alla continua ricerca di nuovo cibo. Se questo caratterizza l’accumulazione capitalistica anche nelle sue fasi espansive, quando la crisi di valorizzazione morde e il sistema di produzione si inceppa, si moltiplicano le contraddizioni interne al sistema, che comincia a manifestare tutta la sua fragilità, costringendo il padronato ad azioni sempre più “aggressive” contro il proletariato mondiale. La recente strage di imprenditori italiani avvenuta a Dacca, oltre che confermare la strategia del Califfato di portare la guerra all’Occidente ovunque, sta a testimoniare come oggi non siano solo i grandi marchi (Benetton, Diesel, ecc.) a investire in Bangladesh, così come in Cina o in India, ma che anche l’imprenditoria “minore” si è adeguata ai tempi ed è andata a investire in paesi dove la manodopera costa un decimo di quanto costerebbe in Italia. Se sul piano della produzione oggi è molto facile abbattere i costi e aumentare i profitti semplicemente andando ad impiantare fabbriche in questi paesi (la cosiddetta “delocalizzazione”), mantenendo in Italia solo ciò che viene definito come “eccellenze”, la stessa operazione non è possibile per quella infinità di servizi e di attività economiche che risulta indispensabile per il funzionamento complessivo del sistema: basti pensare che, dal 1992 ad oggi, il numero di occupati nell’industria è passato da 5.398.000 a 4.496.000, mentre quello degli occupati nei servizi è passato da 12.988.000 agli attuali 15.761.000. Questi numeri, da soli, rendono l’idea di come si sia trasformato il mercato del lavoro in Italia, tenendo presente che il maggior calo occupazionale nel settore dell’industria è avvenuto soprattutto nei grandi poli industriali, in particolare in quelli dell’auto, del tessile e della chimica, che hanno rappresentato in Italia la vera forza del movimento operaio degli anni Settanta e Ottanta.
All’interno di questa grande riorganizzazione del mercato e della necessità di estrarre sempre il massimo profitto dal lavoro umano, nell’ultimo ventennio governi e padronato, in Italia come in Europa, hanno agito di concerto esattamente come sopra descritto, cercando di estrarre il massimo plusvalore sull’intero mercato mondiale, applicando tattiche diverse e un’unica strategia: introdurre nuove leggi per cancellare le tutele previste da leggi precedenti, frutto di cicli storici di lotte operaie e conquiste fatte; e introdurre nuove modalità operative, qualificate come “flessibilità”, le quali, tradotte nel concreto, hanno significato più lavoro senza più regole e meno salario. I settori che hanno maggiormente subito queste scelte di politica economica sono stati soprattutto quelli dei servizi, ma anche nell’industria non si è scherzato: anche qui, infatti, l’uso di forza lavoro precarizzata è stato massiccio grazie a tipologie di contratti che hanno reso maggiormente ricattabile il lavoratore.
Il progetto del capitale si muove quindi su più piani: quello internazionale, volto a garantire la produzione di beni tramite forza lavoro ridotta in schiavitù, da un lato e, dall’altro, quello dei paesi dell’occidente capitalistico, introducendo forme di sfruttamento che puntano a cancellare ogni diritto acquisito, arrivando a ripristinare anche qui il lavoro schiavistico.
È questo il caso della logistica, settore divenuto strategico per i processi di accumulazione; ma è anche il caso di settori quali quelli delle pulizie, del commercio e del turismo, dove l’arrivo di una forza lavoro immigrata ha agevolato forme di sfruttamento selvaggio e senza alcuna tutela, magari garantite da leggi liberticide sul permesso di soggiorno e di asilo e, sul piano del lavoro, dalla forma societaria della cooperativa, dai contratti part-time, dai tempi determinati, dai contratti a chiamata, dai voucher, ecc. È quanto succede soprattutto nel comparto agroalimentare, dove è in atto una vera e propria tratta di schiavi attraverso l’utilizzo massiccio nei campi di migliaia di braccianti e raccoglitori provenienti in gran parte dall’est e dall’Africa subsarahiana, pagati spesso meno di 3 euro l’ora, quasi tutti accampati in ghetti o baracche fatiscenti e, per questo, grazie alla famigerata legge Lupi, resi ancor più ricattabili dalla scure dei permessi di soggiorno legati alla residenza.
L’offensiva padronale di questi anni si è sviluppata con maggiore veemenza dapprima in alcune categorie tradizionalmente meno sindacalizzate quali il commercio e i servizi, per poi estendersi a valanga in tutto il mondo del lavoro dipendente, in primo luogo attraverso l’uso massiccio di forza lavoro precarizzata inquadrata in tipologie di contratti che rendono ricattabili i lavoratori. Si tratta di un processo di attacco ai salari e, più in generale, al proletariato vecchio e nuovo che non riguarda solo l’Italia ma che è, al contrario, il prodotto di una crisi epocale del sistema capitalistico su scala globale; una crisi persistente da almeno quattro decenni, nel corso dei quali si alternano fasi latenti di stagnazione (presentate come crescita) a deflagrazioni esplosive quale quella cui abbiamo assistito nel 2007-2008 con la crisi dei mutui sub-prime statunitensi che, al contrario di quanto si racconta, è stata solo detonatore sul piano finanziario: le sue basi reali vanno invece ricercate in quella crisi di valorizzazione dei profitti che è il presupposto fondante del processo di “finanziarizzazione” dei mercati e delle conseguenti bolle speculative.
Ripetiamo: il progetto del capitale si muove su più piani: quello internazionale, volto a garantire la produzione di beni tramite forza lavoro ridotta in schiavitù, da un lato e, dall’altro, quello dei paesi dell’occidente capitalistico, introducendo forme di sfruttamento che puntano a cancellare ogni diritto acquisito, arrivando a ripristinare anche qui il lavoro schiavistico, grazie anche all’utilizzo di forza lavoro immigrata spinta nelle metropoli capitalistiche dalla fame e dalle guerre.
In questo contesto si colloca l’azione di due organizzazioni sindacali (Si Cobas e Adl Cobas) le quali, senza mai avere avuto in precedenza relazioni tra loro di alcun tipo e provenendo da diverse esperienze, si sono ritrovate a condurre battaglie comuni all’interno di un settore strategico qual è quello della logistica e dei trasporti: pur non legate da alcun vincolo formale, entrambe hanno applicato l’unica logica che dovrebbe valere in ogni contesto, che è quella di unire le forze per combattere un comune nemico. Unire le forze ha significato anche capacità di coinvolgere altre realtà sociali conflittuali, impegnate sul fronte della lotta contro la precarietà o per il diritto alla casa, in quanto, all’interno dei territori nei quali si sono sviluppate le lotte, il percorso ricompositivo si è dato in forma spontanea determinando un potenziale offensivo di grande rilevanza.
Non ci interessa qui riportare tutte le conquiste fatte in un territorio vastissimo, che va dal Piemonte fino a tutto il Nordest, passando per l’Emilia Romagna e arrivando fino alla Campania. Ma alcuni risultati concreti è giusto evidenziarli, poiché a nostro avviso travalicano i confini della categoria della logistica e trasporto merci e hanno tutta la capacità di indicare una strada percorribile anche per il resto della classe lavoratrice:
siamo riusciti a eliminare quelle che erano vere e proprie forme di lavoro schiavistico attraverso la conquista di contratti regolari, le integrazioni per malattia e infortunio, nonché consistenti aumenti salariali. Su questi aspetti non abbiamo fatto altro, nella prima fase della lotta, che “limitarci” ad imporre CON LA LOTTA il rispetto e l’applicazione di quel CCNL firmato da CGIL-CISL-UIL, che nella realtà, fino al nostro ingresso nei magazzini, è sempre rimasto carta straccia nel 99% delle cooperative proprio grazie alla complicità dei sindacati confederali. Si tratta di un elemento di importanza nevralgica sul piano dell’iniziativa sindacale nella fase odierna, e che solo chi vive sulla luna può pensare di sottovalutare: se solo avessimo conoscenza e contezza di ciò che accade in gran parte dei luoghi di lavoro senza distinzioni geografiche o di categoria, ci renderemmo conto che le norme di quegli stessi contratti nazionali definiti “bidone” nei comunicati e nelle dichiarazioni del sindacalismo di base vengono ulteriormente e sistematicamente disattese e stravolte dai padroni a loro vantaggio, facendo leva sull’assenza totale di ogni minimo livello di vigilanza, controllo e lotta sindacale per la loro applicazione. Da qui, dunque, è stato necessario partire, e da qui siamo partiti: oggi, nel 95% dei magazzini in cui siamo presenti, il SI Cobas e l’Adl Cobas, grazie a dure lotte, hanno imposto l’applicazione integrale del CCNL trasporto merci e logistica e contratti migliorativi di secondo livello, ripetiamo, soprattutto in virtù di migliaia di scioperi territoriali e generali, picchetti e iniziative agitatorie;
siamo riusciti, ove siamo presenti, a stravolgere i meccanismi dei passaggi di livello attraverso l’introduzione di criteri automatici basati sull’anzianità di magazzino da un livello inferiore a uno superiore, a ottenere il mantenimento delle condizioni preesistenti in caso di cambio di appalto e abbiamo obbligato i più grandi corrieri italiani (BRT, TNT, GLS, SDA) a sedersi intorno ad un tavolo per aprire trattative serie che hanno portato, nelle filiere citate, a modificare in meglio il CCNL della Logistica. In molti magazzini, grazie alla spinta e all’iniziativa dei lavoratori e delle loro RSA più combattive, siamo riusciti a strappare consistenti aumenti salariali che vanno ben oltre i limiti del CCNL. Si è inoltre iniziato a mettere in discussione, nella pratica e non su semplici accordi scritti, i ritmi e la metrica dell’organizzazione del lavoro, sfatando il dogma secondo cui la rincorsa alla produttività debba per forza significare un aumento dei carichi di lavoro e, dunque, maggiore sfruttamento. Siamo oggi a un passo dal definire un accordo con i principali corrieri in cui saranno previste maggiori tutele per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, da un lato attraverso un sistema di controlli e rilevazioni sui magazzini atto a prevenire l’insorgenza di possibili patologie e, dall’altro, attraverso l’introduzione di meccanismi assicurativi capaci di garantire un salario decente anche a chi divenga affetto da patologie professionali. Diciamo con questo un sonoro no ai limoni spremuti e buttati: i lavoratori, d’ora in poi, saranno risarciti dai padroni per ogni danno venga loro procurato dal lavoro cui sono costretti.
abbiamo soprattutto conquistato la dignità del lavoro sui posti di lavoro: i “per favore” e “potresti fare” che oggi caratterizzano il rapporto di lavoro nei magazzini in cui abbiamo scioperato testimoniano la capacità e l’enorme potenziale dei lavoratori, nel momento in cui acquistano il coraggio di potersi confrontare su un piano “contrattuale” diverso, finalmente consapevoli del proprio potere e della propria forza.
Ci sembra di poter dire, senza tema di smentita che, in Italia, una situazione del genere, prodotta dall’azione di una parte del “sindacalismo di base” (4 scioperi generali della logistica oltre a migliaia di vertenze territoriali) non si sia mai verificata.
Al contrario di quel che pensa qualcuno, per noi non si tratta di un elemento casuale o del semplice frutto di una “specificità” del settore della logistica che, pure, una sua specificità ce l’ha: al contrario, è il prodotto ragionato di un cambio di paradigma nell’azione sindacale.
La crisi del sindacalismo di base, troppo spesso nascosta dietro ai proclami e le ritualità delle scadenze autunnali, affonda a nostro avviso le sue radici in un colpevole ritardo sul piano dell’analisi dei processi in atto nel capitalismo odierno: per dirla in breve, se la crisi riduce sempre più gli spazi per il riformismo sul piano politico, ciò non può che ripercuotersi sul piano sindacale; e il limite di gran parte del sindacalismo di base sta proprio nel continuare ad assumere un metodo e una pratica d’azione caratterizzata esclusivamente da un’apparente e mera “difesa dell’esistente”, in una fase storica in cui da difendere vi è oramai ben poco e in cui i lavoratori hanno tutto da perdere. Al contrario, le lotte nella logistica dimostrano che è possibile conquistare miglioramenti in termini salariali e dei diritti, ma questo solo a condizione di rompere la gabbia delle regole e delle compatibilità padronali e istituzionali, cioè muovendosi nella chiara modalità della lotta dura, intransigente e militante, l’unica lotta possa oggi porsi in un’ottica anticapitalistica.
Non ci interessa stare qui ad attribuirci dei meriti che pure abbiamo; ci interessa invece cercare di indicare una strada percorribile per saldare le forze sindacali sane, non burocratizzate, per delineare percorsi autentici di relazioni che abbiano come unica finalità quella di incidere realmente nella materialità del conflitto di classe.
È evidente che la risonanza mediatica che ha inevitabilmente accompagnato la lotta della logistica e, soprattutto, il peso effettivo che ha questo comparto nell’attuale contesto economico, ha indotto la parte padronale e statuale a intensificare il suo potenziale repressivo, fatto di cariche violente ai picchetti, denunce, fogli di via, ecc. Al contempo, abbiamo assistito a diversi tentativi di incrinare l’unità di lotta che era stata costruita con palesi azioni strumentali da parte della triplice sindacale, ma anche, purtroppo, da parte di altre realtà del cosiddetto “sindacalismo di base”, le quali hanno cercato di aprirsi un varco in questo settore, dal quale sono sempre state fuori, facendo perno su singoli delegati che avevano fatto un uso privatistico del sindacato, dando credito a figure del tutto screditate all’interno del loro posto di lavoro. Piccole forme di opportunismo, queste, nelle quali inevitabilmente si scivola laddove si punti non a ricomporre realmente le lotte, ma, semplicemente a ritagliarsi un qualche spazio con ogni mezzo necessario, anche offrendo coperture a chi ha attraversato varie sigle sindacali, compresa la Cgil, agendo fattivamente per far fallire scioperi generali di settore. Un siffatto modo di agire rientra in visioni del mondo che non ci appartengono e che, costitutivamente, vanno combattute perché, qualora prendessero piede trasformerebbero l’organizzazione sindacale in organismi ad uso e consumo privato di clan o di cricche etnico/familistiche.
Abbiamo assistito anche a tentativi di rompere il percorso di lotta tanto faticosamente costruito con la comparsa di improbabili nuove sigle sindacali messe su da ambigui personaggi bravi a lanciare proclami quanto a prestarsi ad abbassare la posta quando ci sono serie trattative in corso. Da costoro verrebbero mosse critiche ad un agire che non sarebbe più incisivo come nei primi tempi; critiche che lasciano il tempo che trovano e che nascondono la realtà di un progetto di indebolimento del movimento di lotta a tutto vantaggio dei padroni, tanto più in una fase nella quale tale movimento sta conquistando con alcuni dei principali corrieri nazionali la firma di accordi veri e propri di valenza nazionale, che costituirebbero un precedente storico unico.
Siamo più che favorevoli al fatto che realtà vere, che abbiano cioè una effettiva rappresentatività all’interno dei posti di lavoro, partecipino fattivamente a un percorso unitario di lotta, ma quello a cui abbiamo assistito finora non è stata la ricerca genuina di una relazione proficua che parta da quello che ognuno è al di là della macchina organizzativa che rappresenta; tali soggetti millantano semmai credenziali fasulle sul piano dell’effettivo radicamento nel settore, come spesso fanno Cgil, Cisl e Uil.
Non esistono da parte nostra intenti persecutori nei confronti di qualcuno bensì la necessità di rapportarci con chiarezza con le strutture effettive di rappresentanza dei lavoratori, mantenendo alti i principi e i valori fondanti del percorso di autorganizzazione che abbiamo costruito in anni di grandi conflitti di classe.
Per concludere, riallacciandoci al preambolo iniziale, ribadiamo un concetto basilare: la voracità del sistema capitalistico, in tutte le sue articolazioni, non si combatte a suon di proclami o di millanterie; si combatte semmai sul suo terreno, che è quello della messa in discussione del suo potere gerarchico e disciplinare, strappando giorno per giorno quote di profitto per destinarlo al reddito dei lavoratori, costruendo una nuova soggettività di delegati sindacali veri, in grado di dirigere processi autentici di lotta e, soprattutto, sapendo stroncare sul nascere tutto quello che, all’interno di questo processo, puzza di uso strumentale del sindacato o di falsificazioni grossolane della realtà a fini privatistici.
Per questo abbiamo retto in questi anni, come Si Cobas e Adl Cobas, all’interno di un conflitto di enormi proporzioni, in un settore che movimenta circa 80 Mld di euro all’anno: perché abbiamo messo davanti a tutto una visione autentica del sindacato in quanto strumento dei lavoratori per la conquista di migliori condizioni di lavoro e di nuovi diritti, esattamente quanto serve per una lotta più generale per una trasformazione radicale dello stato presente delle cose. È quello che abbiamo fatto in una fase storica nella quale sono i padroni a presentare rivendicazioni, ed è quello che continueremo a fare nel prossimo futuro mantenendo dritta la barra della coerenza.
Per il Si Cobas Aldo Milani
Per Adl Cobas Gianni Boetto